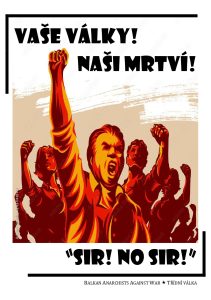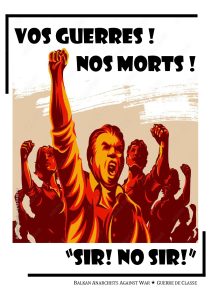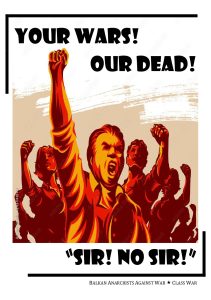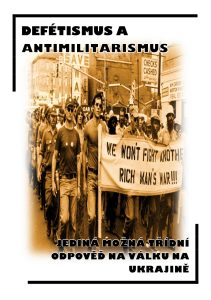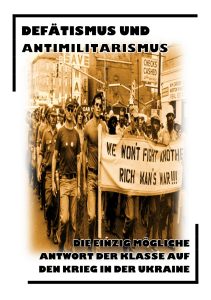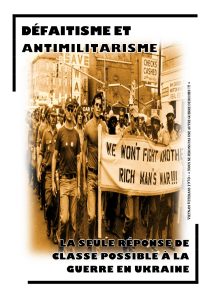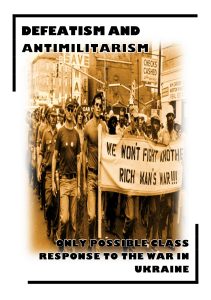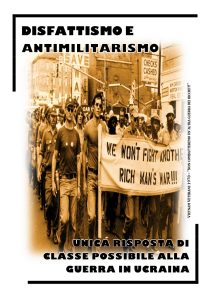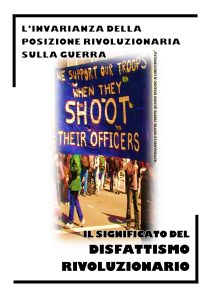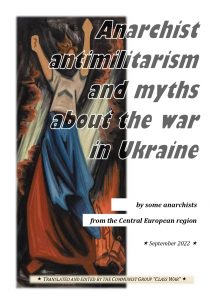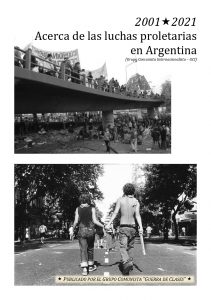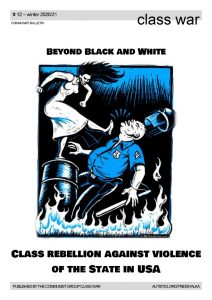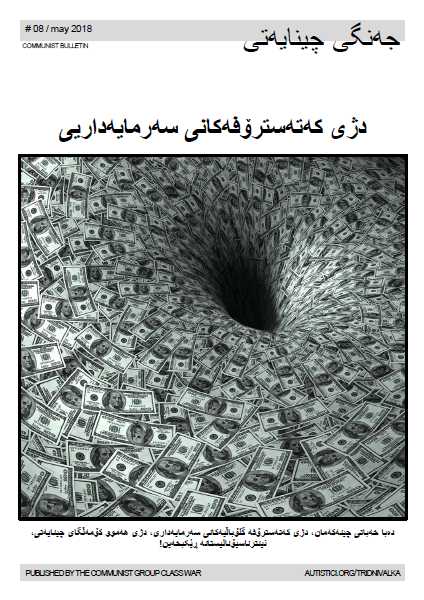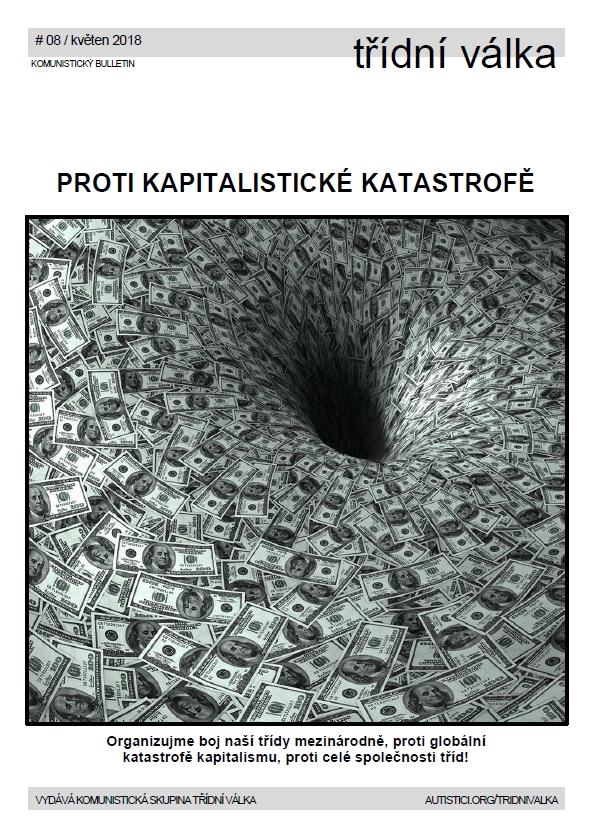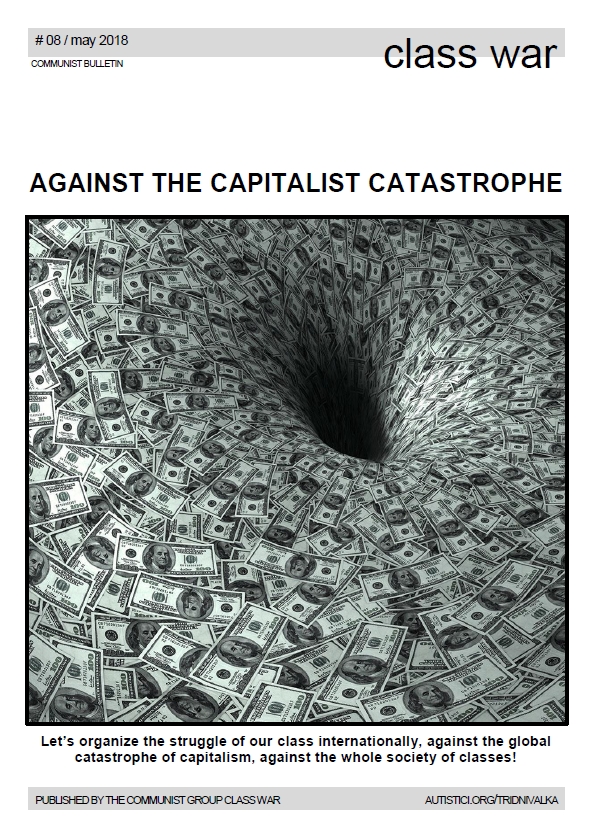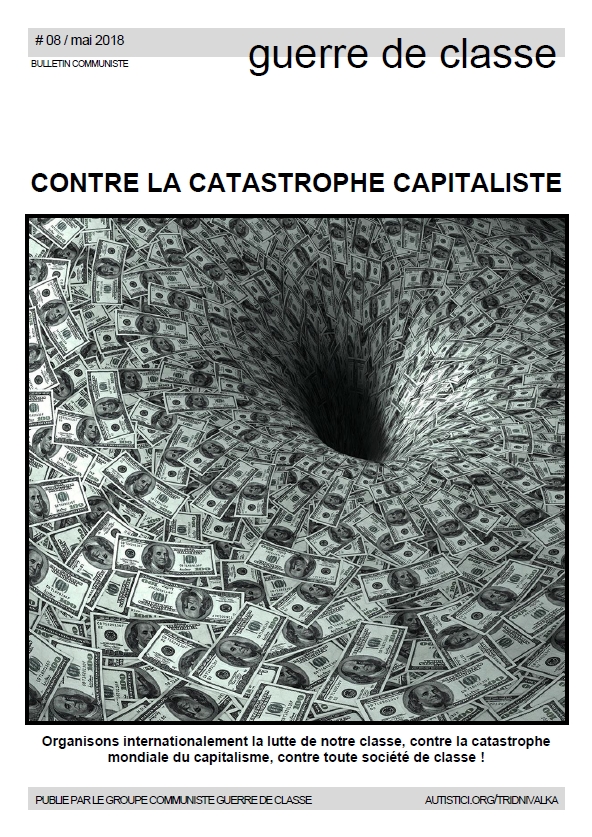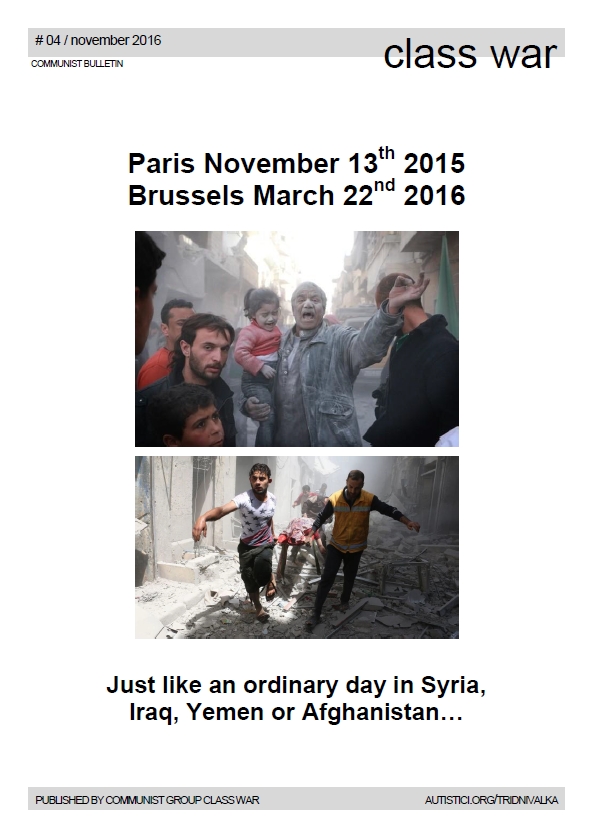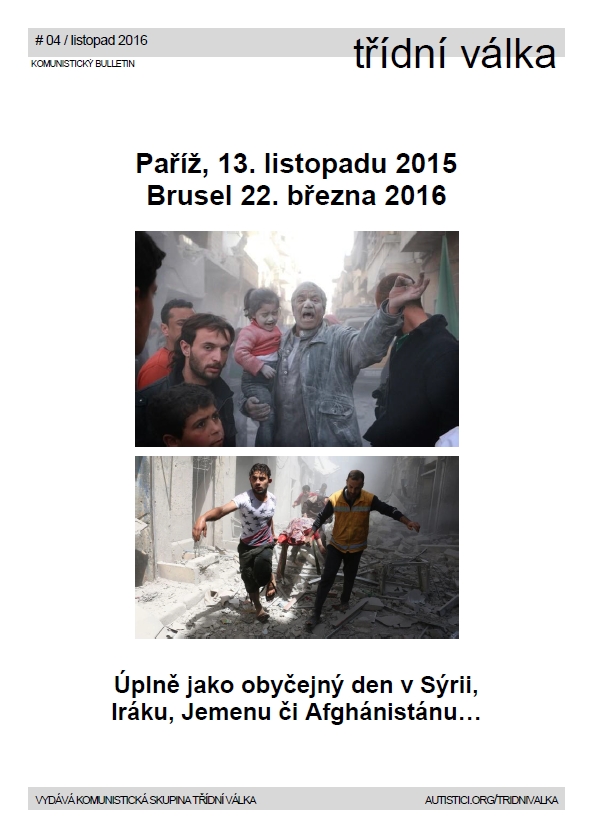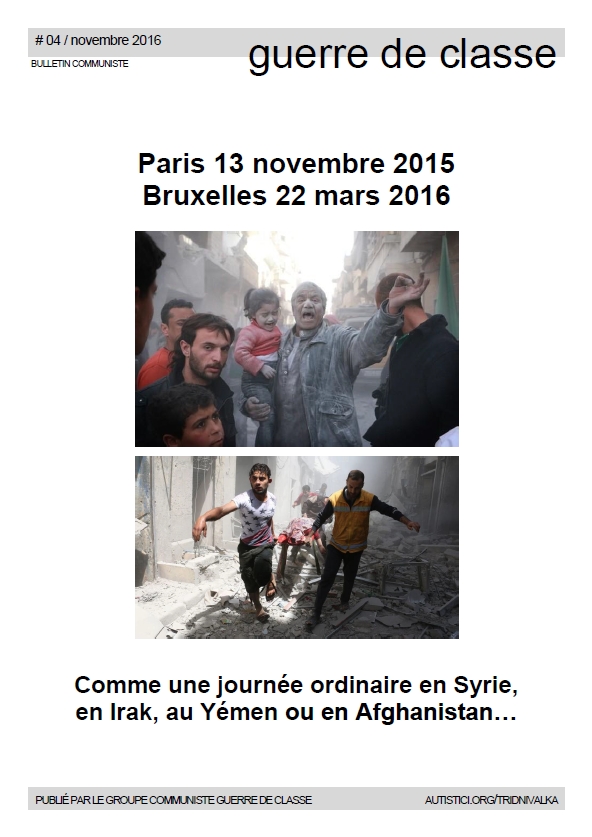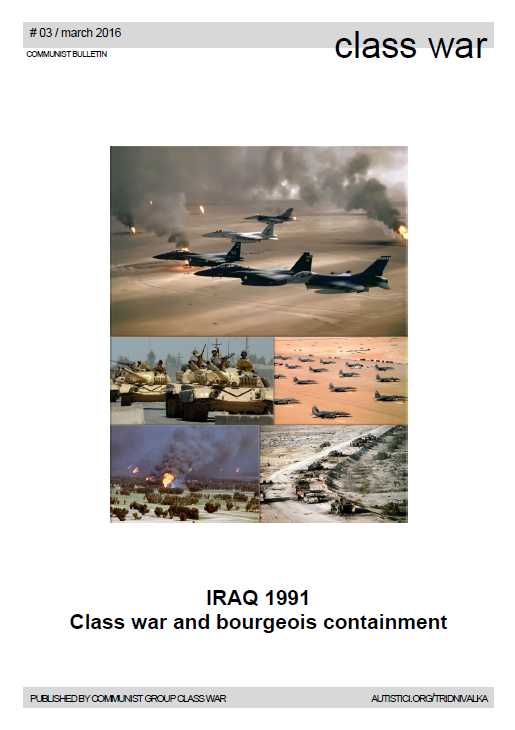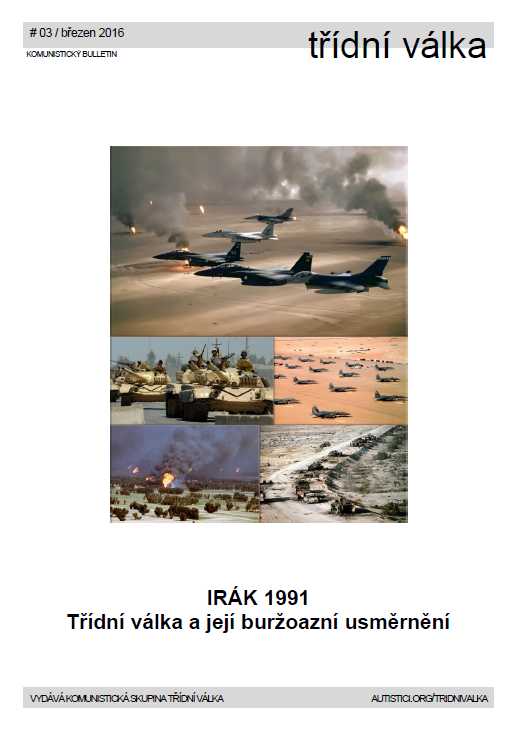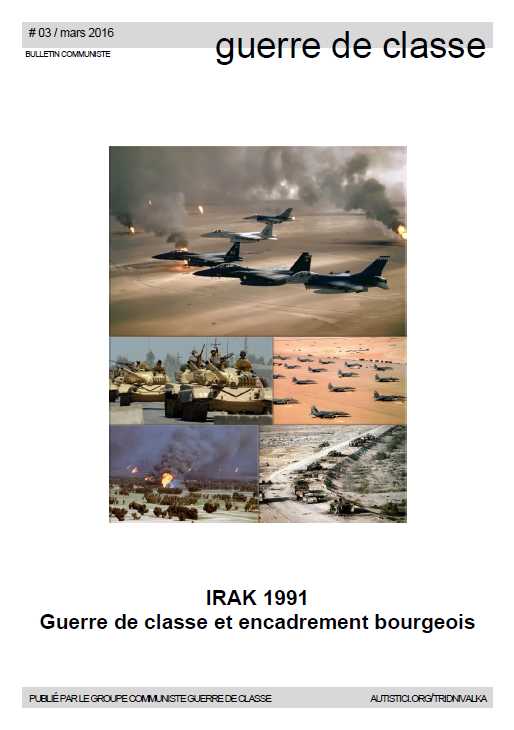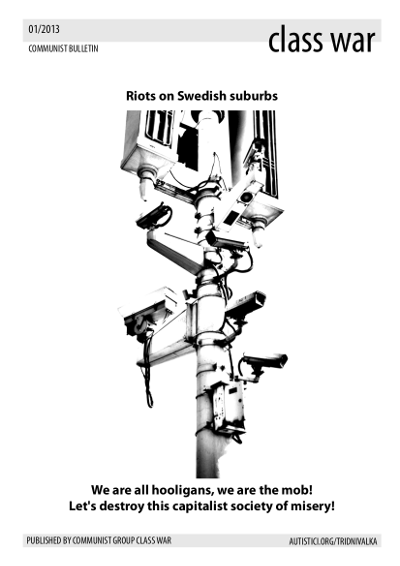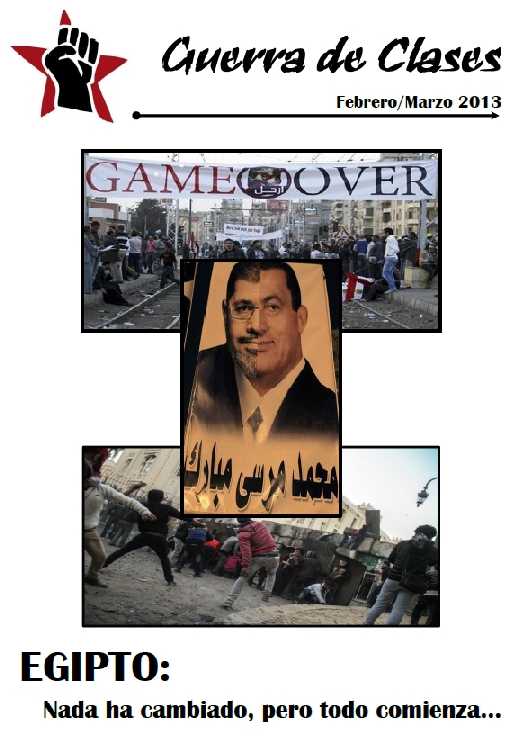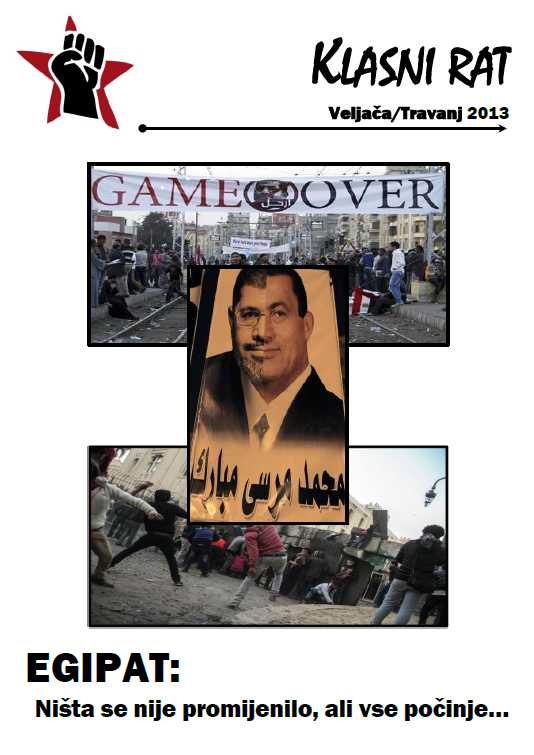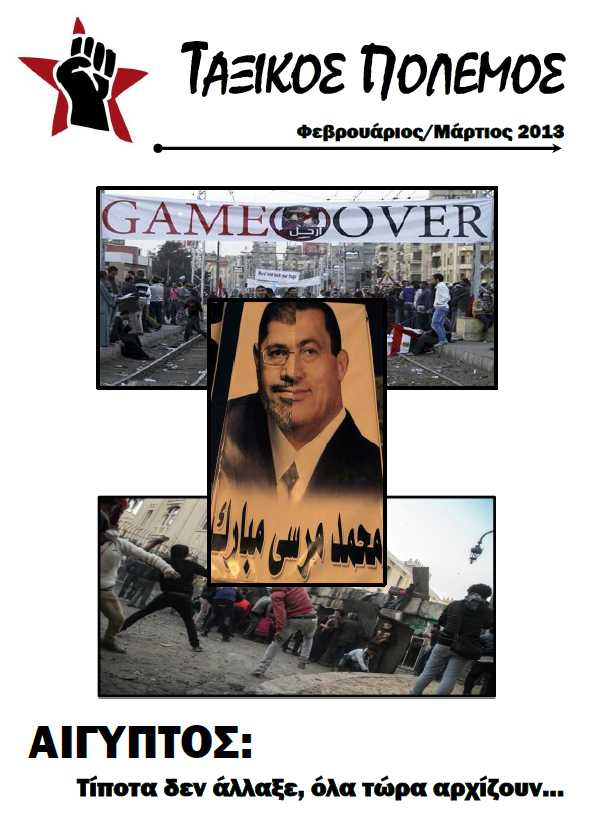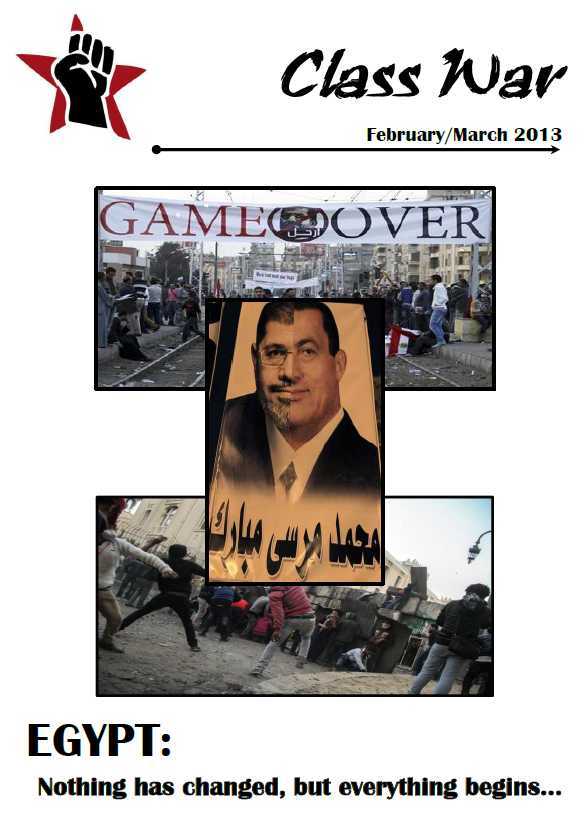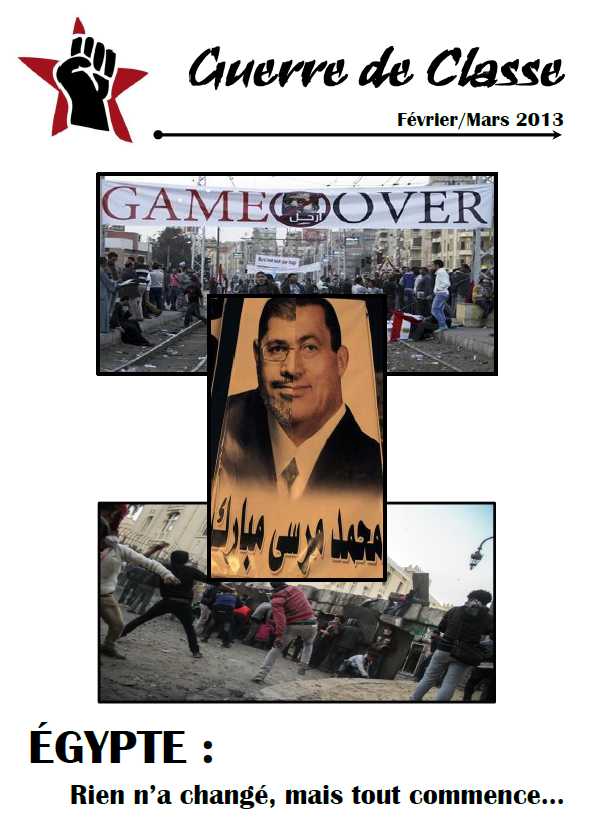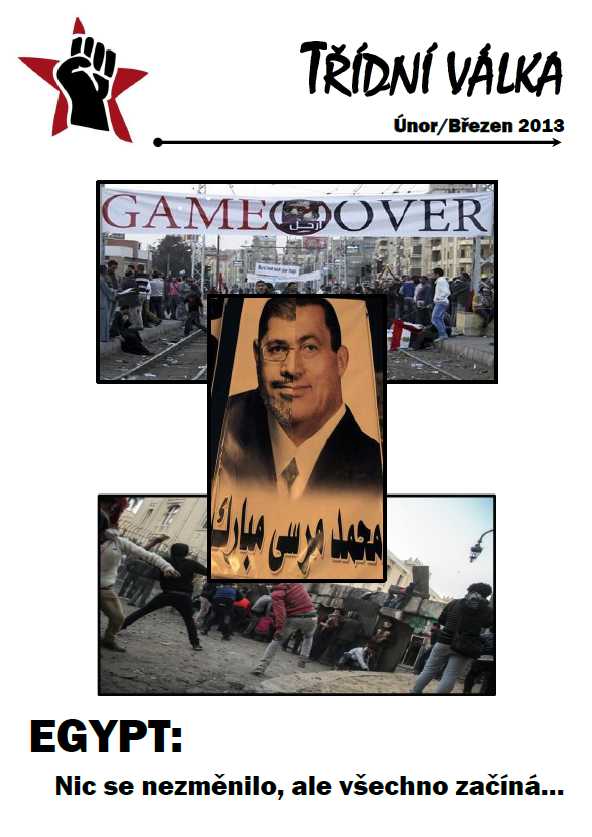/ English / Français / Español / Deutsch / Čeština / Italiano / PDF /
Presentazione di Guerra di classe
Ecco vi presentiamo il testo del Gruppo Comunista Internazionalista [GCI-ICG], originalmente pubblicato nella sua rivista centrale Comunismo n. 54 in 2003, durante rivolta della “Seconda Intifada”. Si tratta di un contribuito molto importante alla decostruzione, denuncia e smantellamento del mito borghese della comunità nazionale, apparentemente riconciliare il conflitto della classe inconciliabile tra gli sfruttati – il proletariato e gli sfruttatori – la borghesia.
Contro questo mito, che nel territorio di “Israele/Palestina” prende la forma di sia “la patria per gli ebrei” sia “la liberazione nazionale palestinese”, questo materiale impone la prospettiva della soggettività militante proletaria. Porta avanti molti esempi della lotta di classe nei territori controllati sia dal governo palestinese guidato dal Fatah e, al momento della stesura non ancora parte del governo, già ascendente e svolgendo il suo ruolo della socialdemocrazia islamica – Hamas, sia dal regime sionista. Ora, Hamas è diventato la fazione al potere in Gaza, e la brutalità e intensità della guerra, in particolare la tattica del sterminio dalle IDF hanno raggiunto i livelli senza precedenti, ma l’insistenza dei comunisti al disfattismo rivoluzionario senza compromessi e contro tutte le falsificazioni borghesi non cambia.
Storicamente le forze socialdemocratiche hanno occasionalmente adottato il concetto del disfattismo rivoluzionario, ma lo hanno applicato in modo così inconsistente – solo alle guerre del passato, alle guerre dall’altra parte del mondo o alle guerre dove non si schiera nessun alleato borghese di loro – che è diventato solo la vuota (e manipolatore) retorica.
Contro questo, il GCI sottolinea l’invarianza e centralità al programma comunista della posizione di disfattismo rivoluzionario, la necessità di lotta per sconfitta del “nostro proprio” campo in ogni guerra capitalista, contro la borghesia in “nostro proprio” paese; necessità di fraternizzazione con i proletari nel campo “nemico”, tutto ciò a prescindere da quale lato del conflitto interborghese è considerato “l’aggressore” o “l’aggredito”, “l’oppressore” o “l’oppresso”, “il colonizzatore” o “il colonizzato”.
Per sottolineare questo punto, il GCI riferisce a un volantino “Gli operai ebrei, compagni” prodotto da un gruppo RKD (Revolutionäre Kommunisten Deutschlands o I Comunisti Rivoluzionari di Germania) e distribuito nella piena carneficina capitalista del proletariato più grande finora, il primo maggio 1943. Il volantino è allegato nella rivista con le note da GCI, insieme alla corta storia di RKD e altri gruppi rivoluzionari del tempo di “Seconda Guerra Mondiale”.
L’ultimo punto che vogliamo fare riguarda la stessa organizzazione GCI. Noi consideriamo loro attività decennale e loro contribuito alla riappropriazione del programma storico proletario dalla comunità di lotta, di essere dell’importanza particolare e di essere molto vicina alle nostre posizioni. È anche importante sottolineare, che il GCI storico non esiste più. Proprio come nessun’altra organizzazione militante nella storia del movimento, nonostante i sui punti di forza, la non era immune alle contraddizioni interne. Alla fine queste contraddizioni hanno portato hanno portato alla sua dissoluzione come un’organizzazione mantenendo la sua continuità militante. Alcuni ex-militanti (in senso letterale), hanno creato il cosiddetto collettivo “Kilombo” e continua a parlare e segnare i suoi materiali in nome di GCI, ma in realtà hanno completamente falsificato il contenuto programmatico del gruppo a favore di una fantasia ideologica volgare, idealista e predisposta alle teorie di complotto. Dobbiamo avvertire i nostri compagni di questa falsificazione.
Guerra di Classe / aprile 2024
Non siamo né israeliani né palestinesi, né ebrei né musulmani… Siamo il proletariato!
Fonte in francese: Communisme n°54, Aprile 2003
Non c’è, non c’è mai stato e non ci sarà mai un capitalismo senza guerra. Se vogliamo evitare le guerre, dobbiamo abolire il capitalismo. Non c’è altro modo per ottenere un mondo senza guerre.
Ma per abbattere il capitalismo è essenziale che la parte della società che costituisce il suo essere sfruttata, e che si manifesta come la contraddizione vivente alla tirannia economica, si costituisca come un’unica classe rivoluzionaria contro la borghesia, come un unico partito che strutturi la sua forza al di là di ogni religione, ideologia o nazionalità.
L’internazionalismo è la risposta proletaria agli sforzi dei rivali del capitalismo di unire gli sfruttati attorno all’economia nazionale e di farli uccidere l’un l’altro schierandoli dietro le rispettive bandiere: nazioni, regioni, fronti di liberazione nazionale, paesi socialisti, fronti antimperialisti, popoli oppressi… La chiave per superare le contraddizioni in cui il capitalismo cerca di isolare il proletariato e di dividerlo per Stati, sta nel rifiuto assoluto di qualsiasi reclutamento in un campo nazionale. Gli sfruttati di tutto il mondo non hanno interessi in comune con chi li sfrutta, e nulla nelle contraddizioni inter-imperialiste può arrestare il peggioramento, a qualsiasi livello, della loro situazione di sfruttati, nulla nell’equilibrio inter-borghese delle forze può relativizzare il loro interesse a combattere incessantemente la classe capitalista.
Per legare il proletariato ai valori patriottici, la borghesia ricorre sistematicamente a trucchi ideologici che dovrebbero rendere più coerente la finzione nazionale che vende a coloro che domina. I ricercatori accademici borghesi inventano origini preistoriche per la nazione, trovano i suoi primi abitanti e li trasformano rapidamente in un popolo con una cosiddetta comunità di lingua, cultura e religione. Una volta definite queste radici, gli storici trasformano gli aspetti della lotta di classe in lotte di “liberazione”, brandiscono gli eroi locali “morti per la patria”, santificano le sofferenze dei cosiddetti martiri e il gioco è fatto: è nata una nazione. La storia delle “costituzioni nazionali” è piena di leggende volte a giustificare la mistificazione nazionale, a costruire un’unità la cui unica funzione è quella di fornire una copertura ideologica al capitale costituito come Stato, e a consentire al capitalismo di disporre di un proletariato docile e addomesticato, che accetta la sua condizione in nome dell’unione fittizia esistente tra esso e coloro che lo sfruttano.
E nel gioco delle leggende, quanto più gli ideologi nazionalisti riescono a presentare la loro creazione patriottica nelle vesti di una piccola vittima oppressa (che protesta con forza contro la persecuzione imposta da qualche potente rivale), tanto più gli agenti capitalisti riescono a congelare le contraddizioni sociali nella leggenda dell’ideologia nazionale e a costruire un potente consenso nazionale intorno alla cosiddetta nazione oppressa. L’“oppressione dei popoli” è la porta d’accesso ineludibile utilizzata dai capitalisti locali per commettere i loro crimini e far cadere il proletariato nella trappola della difesa nazionale.
In realtà, non esistono né “nazioni oppresse” né “nazioni oppressori”: ci sono solo contraddizioni capitalistiche, nascoste da molte fazioni borghesi, tutte impegnate a far passare in secondo piano lo sfruttamento dietro la finzione nazionale.
Come ogni finzione, la nazione diventa tuttavia una forza molto reale e materiale quando riesce a far sì che l’intera società civile, compresi gli sfruttati, abbracci e difenda la sua ripugnante bandiera, in una sorta di matrimonio tra proletari e borghesi – una sordida unione che permette ai secondi di mandare i primi al massacro in nome della difesa della patria. L’unione patriottica è senza dubbio la materializzazione più importante dell’ideologia nazionale e un fattore decisivo per scatenare le guerre capitalistiche.
Qualunque sia il potere materiale di questa finzione nazionale, in ogni caso, dobbiamo ricordare che lo sfruttato rimane concretamente sottoposto a poliziotti, tasse, repressione, “cretinizzazione”, lavoro, estorsione del plusvalore… e ciò si applica, sia che è bloccato nella patria n. 1 sia che nella patria n. 2. Il proletariato non ha nessuna patria. Il suo interesse è quello di unire le sue forze al di là delle frontiere, al di fuori del terreno predisposto dalle varie fazioni borghesi per condurre le loro battaglie capitalistiche. La vittoria del progetto comunista portato in grembo dalla classe rivoluzionaria dipende direttamente dalla sua capacità di emergere come partito internazionale, come forza apolide e a-nazionale. Questa verità, sottolineata dai rivoluzionari da quando esiste il lavoro salariato, è più attuale che mai e la difficoltà di imporre questa prospettiva sta portando a situazioni sempre più drammatiche.
Quanto sta accadendo attualmente in Medio Oriente è un esempio orribile dell’invariabile e putrida unità di capitalismo e guerra, e delle difficoltà incontrate dal proletariato nel riscoprire la via inevitabilmente internazionalista della lotta per l’abolizione delle classi. Ma le violenti contraddizioni insite in una tale situazione di guerra generalizzata condannano i proletari di entrambe le parti del conflitto a cercare strade diverse da quelle in cui si è cercato di confinarli. Queste strade portano alla lotta diretta contro il “proprio” sfruttatore, alla lotta contro la “propria” borghesia, al rifiuto di sparare sui fratelli di classe, alla costruzione di reti che permettano ai soldati di entrambe le parti di disertare, all’organizzazione della resistenza ai “propri” ufficiali, al “proprio” Stato, al rifiuto di ogni guerra – in breve, all’organizzazione del disfattismo rivoluzionario.
Vorremmo sottolineare alcuni esempi in questo senso e collocarli in una prospettiva storica ripubblicando, alla fine di queste note, un volantino internazionalista scritto in yiddish e distribuito da alcuni militanti rivoluzionari nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale, nel momento in cui la polarizzazione fascista/antifascista cercava di impedire l’unità proletaria. Questi rivoluzionari rifiutavano che l’antifascismo e l’enfatizzazione dei crimini esclusivamente fascisti portassero all’unione tra proletari ebrei e borghesi ebrei. Ripubblichiamo questo volantino con alcune note storiche sui suoi autori.
Israeliano o palestinese, il patriottismo è un assassino
Israele, Palestina. Ogni giorno ci porta una nuova serie di notizie, ognuna più insopportabile della precedente. Davanti agli occhi stanchi di una maggioranza di spettatori indifferenti e quasi silenziosi, convinti della loro impotenza, i mezzi di “imbecillizzazione” dell’opinione pubblica creano un festival quotidiano di immagini che ci permettono di ammirare quasi in diretta le ultime performance delle “arti della guerra”: una casa viene colpita frontalmente dal fuoco di un elicottero, un bambino viene ucciso tra le braccia del padre, un medico raccoglie braccia e gambe nel bel mezzo di una pizzeria, una donna piange la sua famiglia sepolta viva sotto le macerie, un combattente agonizza nel suo sangue ancora fresco… Giorno dopo giorno, politici e intellettuali si alternano per offrire un’opinione tanto circostanziata quanto inoperosa sulle uccisioni quotidiane, i bombardamenti diffusi, le esecuzioni arbitrarie, le demolizioni di case, la distruzione di interi quartieri, le incarcerazioni di massa, i cecchini, gli attentatori suicidi, i carri armati e gli elicotteri onnipresenti nelle città. Oltre ad essere un’ammissione di impotenza, questi commenti fatti da persone falsamente rattristate servono a far conoscere ai cittadini una società in cui ogni aspetto della vita è progressivamente militarizzato e il terrore regna ovunque.
Per confortare l’idiota creato dalla TV, per impedirgli di agire e assicurarsi che vada al lavoro il giorno dopo senza brontolare, i telegiornali sono integrati da notizie sugli sforzi di pace, sull’invio di emissari speciali, sull’approvazione di risoluzioni… Ai posti di blocco israeliani partecipano anche premi Nobel, parlamentari stranieri e pacifisti europei: in breve, tutti sono confortati dal pensiero che persone “autorizzate” stanno affrontando la situazione e facendo tutto il possibile per risolverla. Questo indubbiamente permette al cittadino di accettare di guardare le stesse immagini cruente la sera successiva senza sentire il bisogno di reagire.
Per quanto riguarda i proletari che potrebbero comunque fare qualche domanda, vengono tranquillizzati mentre vengono rassicurati sulla loro incapacità di cambiare il corso degli eventi. Per costringerli a rimanere indifferenti a ciò che i loro fratelli di classe stanno soffrendo in Medio Oriente, vengono sommersi da spiegazioni che riducono metodicamente ogni riflessione su questa guerra a una questione di nazioni rivali o di conflitti religiosi secolari e inestricabili. Sia da destra che da sinistra si sente dire che l’unica soluzione è la creazione di uno Stato palestinese che coesista pacificamente con il suo vicino, lo Stato di Israele. Il massimo di ciò che il pensiero democratico può fare si ferma logicamente alla progettazione di nuovi confini, all’organizzazione di una polizia migliore e alla pianificazione delle condizioni di sfruttamento che risulteranno dal nuovo equilibrio di potere tra gli Stati.
Stato palestinese, nazione israeliana, religione ebraica e musulmana… è in questo circolo di fuoco che l’ideologia dominante cerca di confinare ogni tentativo di cogliere il conflitto, spingendo inevitabilmente – e questo è nell’interesse della borghesia – per una polarizzazione, una demarcazione tra chi difende “gli israeliani” e chi difende “i palestinesi”.
Non si fa mai riferimento all’esistenza di interessi sociali opposti, all’appartenenza a classi sociali diverse. Non si fa mai riferimento al fatto che tra un politico di alto livello e un soldato, tra un fabbricante di armi e un disoccupato, tra un banchiere palestinese e un ragazzo di Gaza che lancia pietre, per esempio, c’è un antagonismo profondo come quello tra il predatore e la sua preda. Per i media, la classe sociale è un mondo che semplicemente non esiste. I giornalisti ignorano volontariamente tutto ciò che separa il giovane riservista israeliano lanciato al fronte dal generale di carriera che lo ha mandato lì. Non importa se il primo è un disoccupato e il secondo un importante azionista: per i difensori dell’ordine, l’importante è infondere nella testa di tutti coloro che li ascoltano che sono prima di tutto israeliani, ebrei. Così come i giovani studenti che, imbottiti di esplosivo, si fanno saltare in aria su un autobus sono associati come palestinesi, come musulmani, con i mullah occulti che li hanno convinti che il martirio è un “dono di Allah” e la via più breve per il paradiso.
La potente realtà della democrazia fa costantemente appello all’ideologia e penetra metodicamente nello spazio sociale fino ai suoi angoli più remoti, assimilando il proletario al “suo” Stato a ogni livello, annegandolo in una falsa comunità nazionale e dissolvendolo nel popolo. La nozione di popolo palestinese, come quella di popolo israeliano, soffoca ogni contraddizione di classe. Materializza l’uguaglianza del mondo della merce, un mondo in cui non ci sono ricchi o poveri, banchieri o rifugiati, proprietari terrieri o braccianti, ma solo l’interesse comune di difendere lo stesso Stato.
Il potere della borghesia potrebbe essere misurato con precisione, oltre che dalla sua pretesa di negare l’avversario proletario, dalla sua capacità di nascondere la propria esistenza come classe. Per questo motivo, e in modo molto complementare, l’ideologia dominante evita di pubblicare gli accordi presi tra determinate borghesie quando si suppone che si facciano la guerra l’una contro l’altra. Quindi, quando si parla di Medio Oriente, non c’è motivo di disturbare la solidità dello scenario basato su “nemici nazionali inconciliabili”. Non si tratta di mostrare il retroscena borghese di questa impostura, un retroscena fatto di grandi abbracci commerciali, finanziari ed economici tra “ebrei” e “musulmani” che si suppone appartengano a campi opposti. Il flusso di informazioni elimina quasi sistematicamente tutto ciò che potrebbe in qualche modo indicare l’esistenza di questi interessi comuni che legano i capitalisti israeliani e palestinesi, indipendentemente dalla loro nazionalità.
Ad esempio, quando l’Autorità Palestinese si è insediata a Gaza, i giornalisti si sono guardati bene dal disturbare il rumore di fondo del telegiornale e non hanno fatto alcun cenno ai grandi accordi di monopolio immediatamente firmati dalla leadership palestinese con le aziende israeliane. Non una parola è stata detta sulle gigantesche transazioni fatte con le aziende israeliane, che hanno permesso a tutta una serie di membri di alto rango dell’esecutivo palestinese di arricchirsi con estrema rapidità. Personalità palestinesi che (per preservare l’affittabilità) si sono affrettate a depositare i loro dividendi in conti bancari… nello Stato di Israele. I giornali ne hanno parlato pochissimo, perché non rientrava nell’ideologia dominante. Che si tratti di israeliani o palestinesi, la realtà dimostra che i capitalisti non hanno altra patria che quella del profitto e che non si fanno problemi, da qualunque parte del confine, a sfruttare i loro connazionali mentre firmano accordi tra loro. Ma questa osservazione sposta l’informazione nel campo della lotta di classe e rivela la funzione essenziale svolta dal patriottismo nell’organizzazione sociale capitalista: sfumare i contorni dell’antagonismo sociale. È improbabile che questa affermazione esca dalla bocca di quei cani da guardia dell’ordine sociale che sono la maggior parte dei giornalisti.
Alla luce della situazione caotica che regna in questa regione e dell’impressionante fuoco di sbarramento ideologico che viene messo in atto per mantenere questa situazione, vorremmo sottolineare che solo il ritorno del proletariato al suo terreno di classe può porre fine alla guerra (in Medio Oriente e altrove), e che questo processo implica necessariamente una rottura chiara e definitiva con le unioni nazionali che ogni Stato si sforza di forgiare. Le rotture compiute dal proletariato in Palestina e la determinazione con cui continua ad affrontare il terrorismo borghese sono un passo importante in questa direzione.
Rompere con la pace sociale in Palestina e resistere al recupero nazionalista e religioso
La continuità della lotta contro tutti gli Stati condotta per anni dal proletariato in Palestina è esemplare. Essa affonda le sue radici nella situazione intollerabile che è stata loro imposta. Parcheggiati per la maggior parte in campi di concentramento come quello di Gaza, i proletari non hanno altra esistenza che quella di un esercito industriale di riserva, una fonte inesauribile di forza lavoro a cui la borghesia palestinese e israeliana vanno ad attingere di volta in volta, a seconda delle loro necessità. Questa concentrazione di proletari disoccupati, pronti ad accettare qualsiasi lavoro a causa della difficoltà di sopravvivere nei campi, permette inoltre alla borghesia di entrambi i lati del confine di mantenere una pressione generale sui salari. Questa realtà conferisce all’esercito israeliano un duplice ruolo: come esercito di occupazione, certo, ma anche come vera e propria forza di polizia regionale che garantisce alla borghesia locale il mantenimento delle condizioni di sfruttamento prevalenti.
È proprio di fronte a queste condizioni estreme di sfruttamento, di fronte a questa repressione particolarmente violenta (necessaria per mantenere tali condizioni), che il proletariato palestinese si è sollevato senza sosta. Innanzitutto contro l’esercito israeliano, il nemico che lo affronta direttamente, il nemico che distrugge le case, umilia i proletari e uccide quotidianamente, ma anche contro lo Stato e la polizia palestinesi, contro tutte le forze che si oppongono alla sua rivolta.
In questo breve testo, il cui scopo è quello di sottolineare alcune azioni nella prospettiva di una risposta rivoluzionaria internazionalista e disfattista alla guerra, non ci addentreremo nella storia delle tante lotte che hanno segnato la combattività proletaria in Palestina, in particolare dopo la creazione di uno Stato palestinese ufficiale. Al di là della continua resistenza agli attacchi di poliziotti e soldati israeliani, ricordiamo solo brevemente i violenti scontri con la polizia palestinese, gli attacchi nelle carceri, la liberazione di prigionieri denunciati come terroristi sia dallo Stato israeliano che da quello palestinese, gli attacchi alle stazioni di polizia, le rivolte diffuse in varie aree, ecc.
L’ultima ondata di rivolte nella Striscia di Gaza, in Cisgiordania e altrove, scatenata proprio quando lo Stato di Israele e l’OLP avevano concordato la creazione del nuovo Stato palestinese, è particolarmente significativa. Afferma un’enorme rottura con la pacificazione sociale intrapresa dallo Stato palestinese, dai suoi leader e dai suoi torturatori della polizia. Dalla decisione internazionale di formalizzare l’esistenza dello Stato palestinese locale, le successive intifade1 nei cosiddetti territori occupati hanno dimostrato quanto poco il proletariato della regione sia disposto ad accettare la “nuova” realtà che la classe dominante intende imporgli.
I proletari stipati nella Striscia di Gaza videro il nuovo Stato palestinese introdurre tutta una serie di misure che favorivano i ricchi commercianti, i banchieri e altri “tre stelle” dell’OLP, che improvvisamente furono in grado di arricchirsi ancora più velocemente. Con il sostegno ai rappresentanti dei clan più ricchi, i ministeri guidati dai grandi proprietari terrieri e l’emergere di una casta di funzionari pubblici palestinesi ben alloggiati e ben pagati che guidano auto nuove… quello che è successo in Palestina è stato lo stesso che è successo in Europa orientale quando è caduto il muro: la borghesia è diventata più visibile e la miseria è diventata più evidente. Secondo la logica capitalista, i soldi dei sussidi dovevano essere utilizzati per “stimolare l’iniziativa privata e gli investimenti”, il che in pratica significava favorire gli imprenditori palestinesi (come i muwataneen, le famiglie benestanti di origine gazana e tutti coloro che erano riusciti ad accumulare capitali durante l’occupazione) e incoraggiare finanziariamente l’insediamento di imprenditori palestinesi della diaspora che desideravano investire di concerto con altri capitalisti stranieri. Allo stesso modo, le donazioni internazionali e i prestiti per l’edilizia sono stati utilizzati principalmente per costruire grattacieli nel centro di Gaza, dove un appartamento costa tra i 45.000 e i 60.000 dollari, molto meno degli appartamenti di lusso che ospitano gli alti funzionari dell’Autorità Palestinese2.
Quindi, per i rifugiati, i lavoratori e i disoccupati della Cisgiordania e di Gaza, c’è poco da festeggiare il nuovo Stato palestinese. Come hanno amaramente osservato, lo spazio a loro disposizione è determinato non solo dall’esistenza di recinzioni elettriche israeliane che proteggono i coloni, ma anche dai limiti imposti dalle esigenze di sviluppo dei capitalisti palestinesi. Ecco come una giornalista [Amira Hass in “Bere il mare a Gaza”] descrive lo spazio limitato a disposizione dei rifugiati a Gaza: “Anche se l’Autorità Palestinese decidesse di tenere tutti i rifugiati nella Striscia di Gaza e di costruire nuove città dalle fondamenta, gli insediamenti ebraici – che occupano il 20% del territorio – rappresenterebbero comunque un problema. E mentre il campo di al-Shatti, ad esempio, avrebbe potuto espandersi a nord, l’Autorità ha scelto di utilizzare quel prezioso terreno governativo per costruire un hotel di lusso”. Cosa c’è di più espressivo di questo spazio lasciato ai rifugiati, per illustrare come il proletariato non entri in nessun piano di espansione capitalista, sia esso israeliano o palestinese? “Perché non possiamo usare la spiaggia?”, ha chiesto un rifugiato palestinese nel 1996. “È l’unico posto dove si può uscire, dimenticare un po’. Stanno costruendo un hotel qui e un club per ufficiali là, e nel mezzo c’è un posto per Arafat. Il nord e il sud, è tutto ciò che è rimasto, e sapete cosa c’è lì? Gli insediamenti”. I proletari che pensavano di lottare per un pezzo di terra dietro le bandiere della “liberazione nazionale palestinese” sono destinati a un’amara delusione: l’unica patria concessa loro dal nuovo Stato palestinese si trova tra i fili elettrici degli insediamenti ebraici e il cemento degli hotel di lusso palestinesi.
Un altro esempio della preoccupazione dello Stato palestinese per i suoi “compatrioti” proletari è il silenzio che ha mostrato, durante la negoziazione degli accordi di pace, sulla questione degli 11.000 proletari palestinesi imprigionati dallo Stato di Israele. Inizialmente, la questione dei prigionieri è stata semplicemente “dimenticata”. In seguito a una serie di proteste, questo punto è stato inserito nell’accordo del Cairo del 1994, ma non è stato fatto nulla per accelerare la soluzione della questione. “Come capo del comitato dei prigionieri, Abed al-Razeq continua a fare visite settimanali ai suoi compagni in prigione. ‘Non ho spiegazioni valide da dare loro sul perché sono ancora detenuti. I prigionieri si sentono come se i loro comandanti li avessero abbandonati sul campo di battaglia.’ (…) ‘I prigionieri non possono credere che i ministri del governo palestinese facciano loro visita nelle carceri israeliane’ (…)”.
In pratica, per il proletariato l’istituzione di un nuovo Stato nazionale significò chiaramente un peggioramento delle sue già miserevoli condizioni di vita. Nel 1996, la disoccupazione era aumentata dell’8,2% in sei mesi, raggiungendo il 39,2%. Mentre nel 1995, i gazesi che avevano la fortuna di avere un lavoro nella Striscia hanno visto i loro salari diminuire del 9,6% e quelli che lavoravano in Israele del 16%. Nel frattempo, la classe capitalista si è arricchita grazie agli accordi con varie aziende israeliane.
Ma non sono stati solo i commercianti a trarre vantaggio dagli accordi di Oslo; anche lo Stato palestinese si è concentrato sullo sviluppo delle sue forze di polizia. È normale che la speranza di un’espansione commerciale capitalistica vada di pari passo con l’intensificazione della repressione.
Nel 1994 abbiamo riferito che la polizia palestinese era appena stata istituita e già imprigionava e torturava le persone; da allora la situazione è solo peggiorata. Già nel febbraio 1995, per mantenere la promessa fatta a Rabin di combattere il terrorismo, Arafat ha istituito il Tribunale militare supremo per la sicurezza dello Stato, che ha intrapreso una serie di processi sommari durante le notti. Nel 1996, le forze di sicurezza palestinesi non hanno più esitato a giustiziare gli “attivisti” e, nel 1997, circa venti persone erano già state uccise nelle carceri del nuovo Stato palestinese.
Gli accordi del Cairo del 1994 tra gli Stati di Israele e Palestina prevedevano il dispiegamento di una forza di 9.000 uomini (tra cui 7.000 membri dell’Esercito di Liberazione della Palestina) a Gaza e Gerico. Appena due anni dopo, le forze di polizia palestinesi erano 21.000, e da allora queste cifre hanno continuato a crescere. La polizia palestinese è diventata rapidamente il principale datore di lavoro e fonte di reddito della Striscia di Gaza. Alle forze di sicurezza generale, di intelligence e di difesa civile previste dagli accordi si sono gradualmente aggiunte la Sicurezza preventiva (che, tra le altre cose, controlla il passaggio dei palestinesi in Israele, un lavoro precedentemente svolto solo dai poliziotti israeliani), l’Intelligence militare, la Guardia presidenziale (Forza 17 e Forza 87 per le “missioni speciali”) e la Pattuglia di frontiera. Ogni ramo della sicurezza mantiene le proprie prigioni (24 nella sola Striscia di Gaza nel 1996), i propri interrogatori e il proprio esprit de corps. Ogni residente di Gaza può essere arrestato più volte dai diversi rami della Sicurezza. Ai dissidenti di Hamas è stato anche offerto di entrare nelle forze di polizia per formare un “dipartimento di moralità” incaricato di combattere la prostituzione, il consumo di alcol, eccetera; alcuni di loro hanno ottenuto immediatamente i gradi di ufficiale di polizia e uno stipendio. In breve, i proletari si affrettarono a sottolineare che a Gaza c’era un poliziotto ogni cinquanta abitanti.
L’esercito israeliano, da parte sua, non aveva ovviamente nulla da dire su questa “violazione” dell’accordo del Cairo. Sperava sinceramente che la polizia palestinese, in parte addestrata da loro, sarebbe stata in grado di assumere con successo il suo compito repressivo. Un esempio tipico di questa felice collaborazione tra forze di polizia è stato l’affidamento ai poliziotti palestinesi del compito di filtrare l’ingresso dei lavoratori palestinesi in Israele al famoso checkpoint di Erez.
“Alla polizia palestinese è stato assegnato il compito di passare al setaccio i lavoratori che si avvicinano al posto di blocco presso una serie di posti di blocco posti lungo il percorso verso il confine. I soldati israeliani di stanza al posto di blocco avevano ammesso quanto fosse difficile per loro resistere alle suppliche dei lavoratori senza permesso che cercavano di passare. La conclusione logistica è stata quella di non aumentare il numero di lavoratori autorizzati a passare il confine, ma di risparmiare ai soldati israeliani il doloroso lavoro di estirpare i gazesi senza permesso, lasciandolo alle forze di polizia palestinesi. (…) Ben presto i lavoratori di Rafah hanno fatto battute amare sulle ‘sette’ stazioni palestinesi che dovevano superare prima di raggiungere il posto di blocco israeliano e sugli ‘stranieri’ che vi erano distaccati”.
Come tutte le forze di polizia del mondo, la polizia israeliana sapeva perfettamente che una polizia locale (community policing, secondo l’eufemismo di moda che ci è stato imposto) sarebbe stata molto più credibile ed efficace di un esercito di occupazione, di un poliziotto “straniero”. Ma il rifiuto di accettare la pace sociale, come dimostrato dalle successive Intifada, ha parzialmente rovinato la storia d’amore tra le forze di polizia palestinesi e israeliane3. Completamente sopraffatto, incapace di mantenere l’ordine, lo Stato palestinese non ha avuto altra scelta che lasciar tornare il suo “padrone”, il suo punto di riferimento per la repressione. L’esercito israeliano è intervenuto ancora una volta, prendendo puntualmente posizione nelle cosiddette città autonome, arrestando e/o assassinando militanti e reprimendo ogni espressione di rabbia proletaria.
Lo Stato palestinese, privo di credibilità dopo tanti anni di polizia, carcere e tortura, non ha avuto altra scelta che giocare ancora una volta la carta dell’“opposizione a Israele”. Ricchi commercianti e politici palestinesi provenienti dall’estero, che hanno avuto appena il tempo di costruire una parvenza di sobborghi eleganti a Gaza, si sono affrettati ad accusare lo Stato di Israele di aver violato gli accordi e hanno denunciato una nuova aggressione. Poi, per essere sicuri che, in quanto capitalisti “meno potenti dei loro rivali israeliani”, non sarebbero stati accomunati al “nemico sionista”, hanno mandato i loro poliziotti e soldati a mescolarsi con la gioventù proletaria arrabbiata e a sparare qualche colpo contro i carri armati israeliani, preparando così l’alibi per una nuova e sordida unione nazionale.
Tuttavia, la retorica anti-israeliana può solo a malapena proteggere l’OLP e la leadership dello Stato palestinese dall’odio di coloro che hanno represso. Yasser Arafat ha stretto la mano a troppi politici israeliani, ha collaborato alla creazione di una forza di polizia locale con il suo cosiddetto nemico, ha permesso la repressione e la tortura, ha imprigionato coloro che lo Stato di Israele chiedeva di imprigionare, ha consegnato prigionieri palestinesi allo Stato di Israele, e così via.
Certo, lo Stato palestinese continua a giocare fino in fondo la carta del “nemico israeliano”, per ricomporre l’unità nazionale interna e nascondere il ruolo repressivo che da anni svolge in tandem con lo Stato israeliano – non ha alternative – ma questo non basta, e l’unione patriottica invocata dall’OLP, pur assumendo la sua funzione disorganizzativa tra i combattenti, rimane piuttosto fragile nei confronti del processo di autonomia a cui sembra pronta una buona parte del proletariato palestinese.
Una delle conseguenze perverse dell’indebolimento della credibilità dell’OLP e di Yasser Arafat è, ovviamente, che altri gruppi nazionalisti e religiosi, come Hamas e la Jihad islamica, sono in grado di rafforzarsi dirottando lo spirito combattivo espresso nei “territori occupati” nelle proprie reti. Questi gruppi traggono enormi vantaggi dalla situazione disperata in cui si trovano i proletari palestinesi, schiacciati dall’enorme macchina da guerra israeliana e confrontati quasi quotidianamente con la perdita di una persona cara, di un genitore, di un vicino. L’intera scienza dei gruppi islamisti consiste nel trasformare l’odio del proletariato per la guerra che gli viene mossa contro (e quindi anche per il suo diretto nemico, coloro che gli sparano addosso) in una ripugnanza omicida “verso gli ebrei” in sé. Proprio come in Francia nel 1940-45, i Francs-Tireurs et Partisans e il Partito “Comunista” hanno cercato di ridurre i margini della lotta anticapitalista al famoso slogan patriottico A chacun son boche! [“A ciascuno il suo unno!”], così oggi gruppi come Hamas e altri stimolano la disperazione di chi non ha molto da perdere, e rivolgono la loro rabbia contro “gli ebrei”, “gli infedeli”, “gli atei”. La funzione di queste bande palestinesi, nazionaliste e/o religiose, è quella di ridurre il violento rifiuto delle condizioni sociali imposte ai proletari in Palestina a una mera guerra – nazione contro nazione – e di trasformare le vittime involontarie della guerra capitalista in assassini convinti dei “nemici della nazione”.
Tuttavia, il successo dei sostenitori del martirologio è relativo. Più di un parente di un giovane proletario inviato al martirio si è rivoltato contro il suo emissario. In un programma girato dalla televisione israeliana con le famiglie di militanti palestinesi imprigionati o uccisi in attentati suicidi, diversi padri e madri hanno esclamato: “Che i mullah che hanno mandato mio figlio al martirio se ne vadano da soli!”. Questa rivolta contro l’uso dei proletari come carne da macello è certamente molto più diffusa di quanto la propaganda ufficiale voglia far credere. D’altra parte, non tutto lo spirito combattivo in Palestina è stato cooptato da queste strutture nazionaliste o religiose; i gruppi militanti continuano a strutturarsi autonomamente, sfuggendo ai troppo facili recuperi nazionalisti e antiebraici. In effetti, esiste un generale spirito di lotta tra il proletariato, che esprime regolarmente un desiderio di autonomia, sia contro l’Autorità Palestinese che contro i gruppi islamisti. Per esempio, nell’ottobre 2002, quando suo fratello è stato ucciso dalla polizia antisommossa palestinese durante una manifestazione contro Arafat, un proletario ha voluto vendicare il crimine e ha giustiziato il capo di questa unità repressiva. I poliziotti palestinesi si misero alla sua ricerca, ma non riuscirono a catturarlo per il semplice motivo che gli abitanti del quartiere in cui viveva intervennero immediatamente per impedirne l’arresto. Lo hanno nascosto e difeso con tutti i mezzi possibili, compreso l’attacco alle auto della polizia. L’Autorità Palestinese ha immediatamente cercato di attribuire questi eventi ad Hamas, ma i residenti locali hanno esplicitamente negato questa accusa. Questa situazione è tutt’altro che eccezionale. Ci sono sempre più situazioni simili, in cui la necessità di agire in un modo che li distingua da tutti i nemici, spinge di fatto il proletariato a contare solo sulle proprie forze.
È nella moltiplicazione di queste azioni di resistenza, e nella conseguente estensione dell’autonomia politica, che possiamo indubbiamente vedere la possibilità di sviluppo della risposta anticapitalista (e quindi internazionalista) del proletariato alle atroci condizioni a cui è sottoposto. Una risposta basata sulla differenziazione di classe piuttosto che su quella nazionale, una risposta che tenga conto della totale opposizione che esiste anche nel campo israeliano tra soldati e ufficiali, operai e padroni, proletari e borghesi, una risposta che stimoli e incoraggi le opposizioni esistenti e che spinga i proletari israeliani in uniforme a identificarsi con la lotta sociale condotta dai loro fratelli e sorelle in Palestina, piuttosto che negli ordini omicidi dei loro ufficiali. Infine, una risposta che escluda dai propri ranghi i falsi amici del proletariato, tutti coloro che cercano di recuperare l’odio di classe e trasformarlo in una lotta nazionale o religiosa, per un nuovo Stato, un nuovo spazio capitalista più adatto alle loro esigenze.
È chiaro che la strada per l’internazionalismo in Palestina oggi passa attraverso una risposta immediata alle umiliazioni e alle torture imposte. Non si tratta di aspettare beatamente che la solidarietà internazionalista nasca spontaneamente dal cervello dei soldati israeliani che li uccidono. È proprio l’azione diretta dei proletari palestinesi contro i soldati israeliani che sparano loro addosso, che li tengono rinchiusi nei campi e che li torturano a costituire il più potente incentivo per i soldati dell’altra parte a rompere con il sindacato nazionale e a rivoltarsi contro i loro ufficiali.
Questa azione diretta del proletariato assume indubbiamente ancora oggi ogni tipo di forma, più o meno confusa, più o meno mirata. I coloni e l’esercito israeliano sono certamente gli obiettivi primari di chi resiste al terrore militare, ma è certo che lo stato di esasperazione del proletariato nei campi, di fronte all’assassinio sistematico dei suoi figli o dei suoi genitori, esaspera il suo desiderio di colpire il nemico a tal punto da rendere a volte più approssimativo il bersaglio previsto, o addirittura il metodo utilizzato4.
Tuttavia, vogliamo sottolineare l’ipocrisia e il cinismo di equiparare, da un lato, una frangia di proletari che cerca di resistere e di gettare la propria disperazione in azioni più o meno suicide, e dall’altro, il nemico di classe sotto forma di questi determinati assassini, addestrati e perfettamente nutriti, che non esitano a sparare ai bambini che si sono rifugiati tra le braccia del padre, a liquidare i feriti trasportati dalle ambulanze, a seppellire vivi gli abitanti che si sono rifiutati di abbandonare le loro case e a lanciare missili contro edifici pieni di proletari.
Di quanto cinismo ha bisogno la borghesia internazionale per cercare di far passare per “terroristiche” le poche reazioni del proletariato nei campi, e per “antiterroristiche” le azioni di quei soldati che demoliscono le case, imprigionano e torturano, o palesemente bombardano le popolazioni dei campi profughi, come è avvenuto di recente a Rafah e Khan Younis, le aree più povere di tutti i territori palestinesi? Come si può paragonare tutto ciò al terrore che questi soldati scatenano quando prendono di mira i serbatoi d’acqua sui tetti, quando sbattono i loro mozziconi di fucile sulle porte delle case per terrorizzare i bambini, quando confiscano i documenti d’identità con il minimo pretesto e quando picchiano i prigionieri con spessi cavi elettrici? Come si può paragonare tutto questo alla situazione nei campi, dove la semplice necessità di un proletario di spostarsi da una città all’altra, da un villaggio all’altro, è soggetta a infinite vessazioni? Per non parlare delle umiliazioni quotidiane: la guardia di frontiera che butta a terra la bancarella di pomodori di un piccolo commerciante, i soldati che vengono a svuotare la spazzatura nei quartieri abitati, i funzionari pubblici che tolgono la corrente a interi quartieri per una bolletta o un’altra non pagata… I guerrafondai israeliani sanno bene che una guerra si vince scoraggiando l’avversario, tanto più se quest’ultimo si manifesta più sul terreno sociale che su quello nazionale. È per questo che l’esercito uccide deliberatamente un numero così elevato di civili, bambini, lavoratori… crimini che finge di piangere come errori. Uno studio dell’associazione israelo-palestinese Physicians for Human Rights (PHR) [Medici per Diritti Umani, nota del traduttore], ha evidenziato che durante i cinque anni della prima Intifada, un bambino sotto i sei anni veniva colpito alla testa ogni due settimane. Recentemente, un cecchino dell’esercito israeliano ha dichiarato a un giornalista che l’ordine era di sparare ai bambini di età superiore ai dodici anni dall’aspetto pericoloso. Possiamo davvero parlare di un errore?
Che ipocrisia invocare il “terrorismo” quando si screditano i rari proiettili proletari che, in risposta a questo terrore, a volte colpiscono il bersaglio! Che sinistra commedia parlare di “lotta al terrorismo” quando ci si riferisce alle azioni dei coloni israeliani, organizzati come veri e propri squadroni della morte, che non esitano ad abbattere proletari disarmati, a torturare e a uccidere i loro prigionieri, il tutto sotto l’occhio benevolo e con la benedizione dell’esercito!
Disobbedendo alla “propria” borghesia, rifiutando la pace sociale e le condizioni di vita imposte a loro, agendo autonomamente, i proletari in Palestina stanno spianando la strada al disfattismo rivoluzionario. Con la loro azione, stanno praticamente incoraggiando i proletari in Israele a disobbedire anche ai loro leader, il primo passo verso una comunità di lotta che trascende le divisioni nazionali e afferma la lotta contro le borghesie di entrambe le parti, contro gli eserciti di entrambe le parti, contro i capitalisti ovunque.
Rotture dell’unione nazionale dello Stato di Israele
Il discredito dei leader ufficiali palestinesi, il rifiuto della pace sociale nella stessa Palestina e la combattività contro i gendarmi israeliani non cambiano, purtroppo, la situazione particolarmente orribile del proletariato nei territori occupati. In parte, ovviamente, a causa della politica perseguita dalla leadership palestinese, come abbiamo visto sopra, ma anche e soprattutto a causa della guerra condotta dallo Stato di Israele. Dallo scoppio di una nuova Intifada in Palestina nel settembre 2000, nella zona si sono verificati massacri su base quasi quotidiana, facilitati ovviamente dall’enorme squilibrio militare a favore dell’esercito israeliano, che si riflette nel freddo conteggio dei morti su entrambi i lati del confine: dal settembre 2000, ci sono stati circa 1.800 morti da parte palestinese e 600 da parte israeliana.
Questo potere militare è radicato nel sostegno incrollabile che lo Stato di Israele riceve dal campo occidentale, e in particolare dagli Stati Uniti, un sostegno che riguarda direttamente la funzione primaria attribuitagli, ossia la repressione generale del proletariato, non solo in Palestina e in Israele, ma in tutta la regione nota per le sue agitazioni sociali. La funzione di gendarme attribuita allo Stato di Israele, di fatto responsabile della repressione di qualsiasi movimento sociale nell’area, consente alla borghesia locale e internazionale di mantenere il controllo sulle risorse petrolifere del Medio Oriente, risorse vitali per l’industria internazionale5. Tradotte in termini finanziari, le cifre del sostegno occidentale riflettono le puntate del gioco imperialista concentrata nella regione. Dal 1984, gli aiuti ufficiali annuali della sola borghesia statunitense allo Stato israeliano ammontano a 3 miliardi di dollari (40% in sostegno economico e 60% in sostegno militare). Se a questa somma si aggiungono altri 2 miliardi di dollari di aiuti cosiddetti indiretti (vari programmi militari speciali, sostegno militare dal bilancio della difesa, garanzie non richieste, ecc.), si arriva a una somma annuale approssimativa di 5 miliardi di dollari, che costituisce circa un terzo del bilancio degli aiuti esteri degli Stati Uniti6.
Ma, a parte il sostegno militare diretto dell’Occidente, qual è la base di questo squilibrio di potere a favore dello Stato di Israele? Come in ogni guerra, è costruito principalmente sulla forza dell’unità nazionale, un’unità che si estende ben oltre i confini dello Stato ufficiale e che, alimentata dalle campagne internazionali antiterrorismo, sussurra che “Israele ha semplicemente il diritto di difendersi dal terrorismo”, un diritto riconosciuto anche dallo Stato palestinese. La lotta “contro il terrorismo” è la porta d’accesso alla repressione, una vera e propria licenza internazionale di uccidere data da tutte le fazioni che sostengono stabilmente la repressione attuata dallo Stato di Israele, in particolare Stati Uniti ed Europa.
Il sostegno internazionale al ruolo repressivo svolto dallo Stato di Israele nella regione rende ovviamente fondamentale questa unione nazionale, un’unione particolarmente organizzata intorno all’esercito: militarizzazione onnipresente, servizio militare estremamente lungo e promosso, giustificazione del presunto ruolo protettivo di Tsahal, costruzione di pregiudizi favorevoli ai soldati, economia militarizzata, popolazione militarizzata, ecc.
Questa situazione iper-militarizzata è purtroppo poco messa in discussione dai proletari in Israele, nonostante lo sviluppo che la lotta in Palestina ha conosciuto e sta tuttora vivendo. Infatti, le ripetute rivolte in Cisgiordania e a Gaza non hanno purtroppo impedito ai proletari in Israele di mantenere una colpevole indifferenza nei confronti dei massacri compiuti dall’esercito israeliano, quando non si sono semplicemente allineati ai piani messi in atto dalla borghesia israeliana per schiacciare le ripetute intifade. Va detto che, per la maggior parte, i proletari di Israele si sono limitati a riprodurre l’ideologia del loro nemico di classe che, nel contesto degli scontri sociali in atto in Palestina, ha conseguenze particolarmente gravi per i loro fratelli di classe.
Le giustificazioni delle azioni compiute dall’esercito israeliano si basano, ovviamente, su una varietà di ideologie, a seconda delle fazioni che le esprimono: i rabbini benedicono le armi che uccidono i palestinesi in nome della “lotta contro il male”, mentre i laici – guidati dal premio Nobel per la pace Shimon Peres – stigmatizzano la “lotta contro il terrorismo”. Ma tutti si appellano alla “madrepatria”, anzi all’“esercito-madre”, un esercito che non si chiama nemmeno più “esercito”, ma si porta dietro il suo piccolo nome – Tsahal – come a differenziarsi dagli altri, come a significare il carattere protettivo e benevolo dei suoi assassini.
Inoltre, per quanto diverse possano essere le spiegazioni di questa guerra di distruzione condotta dallo Stato israeliano, esse sono tutte cementate in una sorta di rivendicazione mistica delle sofferenze passate del “popolo ebraico” come garanzia indiscutibile per l’azione presente. Come ovunque, ma ancora di più qui, lo Stato impone la giustificazione profonda della sua esistenza in un misto di ideologia e religione, impedendo qualsiasi sfida alla versione ufficiale delle ragioni alla base delle sue azioni. “L’Olocausto è la nuova religione di Stato in Israele”, ha dichiarato un’attrice ebrea israeliana per spiegare la difficoltà di esprimere critiche allo Stato. E in effetti, come le giustificazioni fornite per la maggior parte delle guerre condotte dal campo occidentale negli ultimi decenni, lo Stato di Israele legittima il terrore che l’esercito sta attualmente seminando al suo seguito facendo riferimento all’abisso che separerebbe i propri crimini dalle atrocità commesse contro il proletariato ebraico dal campo sconfitto – lo Stato tedesco – nella cosiddetta Seconda Guerra Mondiale. Questi sordidi paragoni sulla scala degli orrori capitalistici, a parte ciò che oscurano7, sono il cemento di un enorme consenso nazionale in cui ogni sfida al terrorismo di Stato locale si scontra con lo straordinario dogma che nessuna sofferenza inflitta a nessuno potrà mai eguagliare la persecuzione subita dal popolo ebraico sotto il nazismo.
Un accademico di Tel Aviv e attivista contro la guerra di Israele ha recentemente denunciato il cinismo che si cela dietro questo implacabile ragionamento, in quella che ha definito “la logica di Auschwitz”:
“Questa è la logica di Auschwitz in poche parole. Ramallah non è Auschwitz. Israele non è il Terzo Reich. Non abbiamo campi di sterminio e non abbiamo massacrato un terzo della popolazione palestinese in camere a gas. Pertanto, tutto ciò che facciamo va bene. Possiamo riempire i territori occupati di gas lacrimogeni e sangue, possiamo uccidere e ferire e torturare e ricattare ed espropriare, possiamo circondare milioni di persone con recinzioni elettriche e carri armati in minuscole enclavi, possiamo tenerle sotto assedio e bombardamenti quotidiani, possiamo far camminare le donne incinte fino agli ospedali, e spariamo anche alle ambulanze, non è vero? Ma finché non siamo nemmeno lontanamente paragonabili alle atrocità della Germania nazista, va tutto bene e non osate fare paragoni.
A volte si dice che il Meglio è il più grande nemico del Bene. Israele sta dimostrando come il Male maggiore sia il miglior amico del Male.
E grazie ad Adolf Hitler per aver fissato standard così insormontabili”.8
Queste note non prendono esplicitamente il punto di vista del proletariato, eppure sono valse al loro autore una serie di minacce e intimidazioni. Questo testimonia la logica ferrea con cui la nostra classe si confronta con lo Stato di Israele ogni volta che viene mossa la minima critica. Attaccare la religione dell’Olocausto in Israele è peggio che mettere in discussione il dogma che giustifica la democrazia in Europa occidentale. Se vediamo, ad esempio in Occidente, come ogni reazione che tenti anche solo di allontanarsi dal parlamentarismo venga liquidata come “filofascista”9, possiamo immaginare il terrore che ogni critica alla religione dello Stato locale deve rappresentare per un proletario in Israele, il che ovviamente non giustifica la mancanza di solidarietà pratica con il fratello in Palestina.
E che dire di coloro che criticano l’esercito e di tutti coloro che cercano di resistere al reclutamento militare diffuso? L’obiezione di coscienza, soprattutto in tempo di guerra, è un reato simile all’alto tradimento10. Anche un approccio pacifista assume una dimensione diversa. Distribuire un semplice volantino che chiede la fine della guerra o che si oppone allo sviluppo delle colonie significa rischiare la vita di fronte ai militanti del Kach o ai coloni.
L’unità nazionale è quindi molto potente in Israele e, come abbiamo sottolineato, il proletariato è praticamente dissolto. Ciò rende ancora più interessante notare le poche rotture dell’ordine sociale locale emerse negli ultimi tempi, rotture che sono partite dai soldati israeliani e che sembrano estendersi ad altri settori.
Il 26 gennaio 2002, 53 ufficiali e soldati di riserva dell’esercito israeliano hanno annunciato pubblicamente il loro rifiuto di “partecipare alla guerra per la pace degli insediamenti. Non continueremo a combattere oltre la linea verde [i territori occupati] per governare, espellere, distruggere bloccare, assassinare, affamare e umiliare un intero popolo”. L’appello è stato pubblicato dal quotidiano israeliano Haaretz.
Non si tratta della prima reazione di questo tipo, poiché già nell’agosto 2001 62 studenti avevano reso nota la loro decisione di non rispondere a un eventuale invio nei territori, per motivi politici. Ma questa reazione, pubblicata su un giornale israeliano sotto forma di annuncio e firmata direttamente da soldati in servizio, ha portato alla luce una realtà che di solito viene accuratamente nascosta.
Come i 53 firmatari sopra citati, più di 400 riservisti e soldati israeliani, dall’inizio della nuova Intifada (settembre 2000) [questo articolo risale al marzo 2003], hanno reso pubblico il loro rifiuto di combattere nei “territori occupati”, e circa 40 di loro sono stati mandati in prigione per questo. Yair Hilu, 18 anni, è stato condannato al carcere militare per essersi rifiutato di prestare il servizio militare “in questa entità violenta che è l’esercito”, secondo le sue stesse parole. Lo Stato israeliano ovviamente non promuove molto questi dati (e nemmeno lo Stato palestinese, se è per questo). È quindi difficile conoscere il numero esatto di proletari che si sono rifiutati di combattere, ma si stima – sulla base delle stime dell’esercito stesso – che per ogni persona che ha reso pubblico il suo rifiuto di servire lo Stato, altri 8 o 9 soldati esprimano la stessa posizione, senza osare confrontarsi direttamente con i loro superiori. Già durante la prima Intifada (1987-1991), più di 2.500 soldati si sono chiaramente rifiutati di andare in Cisgiordania e a Gaza, il che significherebbe, sulla base dei calcoli fatti in precedenza, che circa 20.000 persone si sono rifiutate di andare a confrontarsi con la repressione dello Stato in un modo o nell’altro.
L’esercito israeliano relativizza questa realtà e, nonostante le testimonianze e il numero crescente di dichiarazioni in merito, ripete costantemente che “il morale è buono” e che i “soldati sono motivati”. Eppure le reazioni dello Stato non lasciano spazio a dubbi sul timore che il rifiuto di obbedire si diffonda. Un segno evidente di ciò è il modo in cui le autorità militari israeliane evitano di sbattere sistematicamente in prigione i soldati refrattari, per non creare troppo scalpore intorno al rifiuto di servire. D’altra parte, poiché si afferma un più generale rifiuto del sistema, chi si oppone troppo allo Stato ha apparentemente diritto a un trattamento particolarmente umiliante, volto a fungere da esempio e a scoraggiare altri renitenti. Un altro segnale è il divieto per tutti i giornalisti stranieri che non lavorano per il servizio informazioni dell’esercito israeliano di riferire su qualsiasi argomento. Questa decisione è stata presa dopo che diversi soldati coscritti, intervistati direttamente sui campi di battaglia, avevano espresso davanti alle telecamere il loro sconcerto e la loro incomprensione degli obiettivi di questa guerra. Ma il timore di una disobbedienza sociale da parte del proletariato ha assunto una forma ancora più evidente con l’adozione, il 22 maggio 2002, del piano di austerità presentato da Sharon, che prevede una riduzione delle indennità per le famiglie i cui figli non hanno completato il servizio militare. L’unità nazionale incondizionata intorno alla guerra condotta dallo Stato di Israele è chiaramente in gioco in queste misure particolarmente mirate.
L’obiettivo è impedire il sostegno a coloro che vengono denunciati come “sabotatori del morale della nazione”. Questo è il problema che la borghesia israeliana deve affrontare oggi: come impedire che le domande poste dai proletari in uniforme si trasformino in una risposta sociale e rivoluzionaria da parte del proletariato nel suo complesso? Per quanto deboli possano essere ancora le reazioni sparse dei proletari in Israele alla guerra, esse contengono i semi di una polarizzazione sociale che potrebbe trasformare la guerra tra lo Stato israeliano e quello palestinese in uno scontro di classe; uno scontro tra, da un lato, i difensori borghesi della nazione e del capitalismo e, dall’altro, una classe sociale che prende coscienza del fatto che la difesa della nazione è solo una costrizione e un’estensione degli interessi di coloro che ci sfruttano.
Per illustrare questi semi di polarizzazione sociale, basta guardare al primo appello di 53 soldati israeliani a smettere di combattere “nei territori occupati”, e le reazioni che ha provocato. Se ci limitiamo a dare un’occhiata al testo, vedremo che contiene molti punti deboli: i firmatari giustificano i sacrifici fatti in passato per lo Stato di Israele, prendono come riferimento la sicurezza dello Stato, si rammaricano del deterioramento dell’immagine “umana” (sic!) dell’IDF e affermano di continuare a servirlo. Ma la cosa più interessante non è tanto quello che dicono, quanto l’atto in sé. Il fatto che, nel contesto di un’unione nazionale così compatta come quella prevalente in Israele, i soldati osino rifiutare le istruzioni dei loro superiori e mettersi così apertamente in contrasto con gli interessi della loro borghesia (con tutto ciò che questo comporta anche in termini di repressione sociale, insulti, disprezzo e isolamento da parte della maggioranza dei cittadini) conferisce un peso molto maggiore a questa posizione controcorrente. Non si tratta di una reazione antimilitarista in un contesto di pace sociale o di “permissivismo” della democrazia parlamentare, ma di una rottura con uno degli Stati più coesi a livello nazionale del mondo, uno Stato che svolge un ruolo di polizia decisivo nella regione. Rifiutarsi di combattere per Tsahal, denunciando le sofferenze inflitte ai proletari della Palestina su cui dovrebbero sparare, equivale a confrontarsi direttamente con tutta questa coerenza politica ricavata dalla mitologia del popolo martire e armata con l’ideologia dell’antifascismo internazionale, cioè il cemento degli Stati vincitori e dominanti dalla seconda guerra mondiale. È un confronto insolito.
Ecco perché questo appello ha visto immediatamente i suoi autori (e coloro che li hanno sostenuti) bollati come “revisionisti”, “traditori”, “ebrei che odiano se stessi” e persino “antisemiti”. Anche il giornale che ha pubblicato il manifesto è stato denunciato e molti intellettuali ne hanno preso immediatamente le distanze. Per contrastare gli effetti disfattisti di questo appello e l’entusiasmo che suscitava in molti proletari, che finalmente vedevano scritto molto chiaramente ciò che molti già pensavano ma non osavano formulare, lo Stato reagì immediatamente con il suo intrinseco terrorismo. Il ministro dell’Istruzione, Limor Livnat, ha chiesto l’incriminazione di 200 accademici che hanno sostenuto questi soldati che si rifiutano di prestare servizio nei territori palestinesi. La stampa borghese e religiosa ha invitato a sostenere il morale dei soldati, come il quotidiano Yediot Aharonot, che il 7 maggio 2002 ha pubblicato le lettere dei bambini delle scuole pubbliche religiose che invitano i soldati a “uccidere quanti più arabi possibile”, a “sparare ai palestinesi con gli F-16”, ecc. Allo stesso modo, il Parlamento israeliano sta esaminando un progetto di legge che punirebbe con cinque anni di reclusione l’“espressione di sostegno a un’organizzazione terroristica” (e quindi condannerebbe qualsiasi contatto con un’organizzazione palestinese).
Ma in un modo o nell’altro, e anche se è presto per parlare di un movimento diffuso, se questo breve testo ha generato così tante reazioni da parte dello Stato, è perché rivela le falle che tendono a formarsi nell’unità nazionale. Dalla pubblicazione di questo testo, nel gennaio 2002, il numero dei firmatari è cresciuto. Al momento della stesura di questo testo, i firmatari erano 1.100, di cui più di 250 finiti in carcere. Ma al di là di questa iniziativa, altre informazioni parlano di più di mille proletari israeliani che rifiutano in un modo o nell’altro di prestare il servizio militare, come soldati coscritti, riservisti o addirittura ufficiali. Sono ormai noti come refuseniks e secondo varie associazioni, con la dovuta cautela nel citare le cifre, il loro consenso all’interno della società arriverebbe al 25%.
Si sono verificate anche altre iniziative pubbliche simili a quella dei 53 firmatari. Ad esempio, una lettera di Sergio Yahni, condirettore del “Centro di Informazione Alternativa”11, inviata il 19 marzo 2002 al Ministro della Difesa Ben Eliezer, ha avuto un certo riscontro. In una più profonda contraddizione con lo Stato, Yahni affermava il suo rifiuto non solo di combattere nei territori occupati, ma anche nell’esercito israeliano in tutte le sue forme: “Come ebreo”, scrisse, “sono respinto dai crimini che questa milizia commette contro il popolo palestinese. È mio dovere ebraico e umano rifiutare risolutamente di prendere parte a questo esercito. Come figlio di un popolo vittima di pogrom e distruzione, non posso far parte delle vostre folli politiche. Come essere umano, è mio dovere rifiutare di partecipare a qualsiasi istituzione che commetta crimini contro l’umanità.” […]12
I riferimenti ai “crimini contro l’umanità” e ad altre espressioni feticistiche dello Stato israeliano, utilizzati con sempre maggiore frequenza dai proletari ebrei per denunciare le politiche della borghesia israeliana, mostrano anche che la coesione nazionale costruita sul passato martirio è sempre meno solida. È anche un segno interessante dell’erosione dell’unità nazionale. La nazione israeliana può essere sigillata da una serie di fattori estremamente potenti, che radicano la leggenda aclassista di un popolo ebraico in una grande tragedia storico-religiosa la cui funzione è quella di congelare ogni contraddizione sociale, ma non può impedire al proletariato di rivoltarsi contro il degrado materiale delle sue condizioni di esistenza.
Tra coloro che ieri proclamavano il loro sostegno incondizionato allo Stato di Israele sulla base del mito della Terra Promessa, del Popolo Eletto, sulla base delle difficoltà di costruire questa piccola patria in mezzo al deserto, sulla base delle sofferenze patite durante la Seconda Guerra Mondiale… molti di loro oggi trovano sempre più difficile giustificare in questo modo l’attività terroristica e omicida dello Stato israeliano. La guerra e il peggioramento della situazione sociale mettono sempre più proletari israeliani in contrasto con l’ideologia della “loro” borghesia. Cancellazione dei sussidi, aumento delle tasse scolastiche e dei costi sanitari, piani di austerità sempre più dolorosi, uno spazio vitale completamente militarizzato, repressione di qualsiasi alternativa, una crescente disparità tra ricchi e poveri, un visibile e spettacolare aumento dei tassi di suicidio13… tutti questi elementi dell’attuale panorama nazionale portano inevitabilmente i proletari in Israele a considerare materialmente la loro posizione di sfruttati e non di ebrei o israeliani. Da questo punto di vista, una volta messi da parte i miti specifici su cui si basa – miti specifici di ogni nazione – lo Stato di Israele rivela la sua vera natura e appare per quello che è: né più né meno che un volgare Stato capitalista, come tutti gli altri. Al di là dei miti egualitari dei “padri fondatori di Sion” e dei progetti per la Terra Santa, c’è semplicemente la necessità di una classe dirigente che, per garantire il buon funzionamento del capitalismo nella regione, struttura il suo sviluppo intorno alla ricerca del profitto, con tutte le conseguenze che questo comporta in termini di politica interna ed estera. Come ogni classe dirigente, la borghesia israeliana non ha solo bisogno di mantenere l’ordine all’interno dei propri confini per far funzionare le proprie attività, ma deve anche dotarsi dei mezzi per espandersi di fronte ai propri concorrenti. Così, per disciplinare il “loro” proletariato e consentire lo sviluppo imperialista (garantendo al contempo il mantenimento dell’ordine capitalistico nella regione), gli sfruttatori locali esigono un esercito compatto e disciplinato, impongono la coscrizione obbligatoria, sviluppano uno Stato forte, uno Stato capace di reprimere espandersi, colonizzare, deportare, massacrare… insomma, capace di commettere una serie di crimini in tutto e per tutto simili a quelli commessi contro gli ebrei e che sono serviti proprio a giustificare la creazione dello Stato di Israele in Palestina.
E in effetti, la necessità imperativa di conquistare territori costringe lo Stato a rivelare la natura barbarica del suo essere, in Israele come in ogni altra parte del mondo. Di conseguenza, gli ufficiali e i ministri sono costretti a formulare i loro ordini in modo più chiaro, a dichiarare esplicitamente le loro intenzioni. Il mito della nazione martire subisce un duro colpo. Yitzhak Rabin aveva già detto “Gli spezzeremo le ossa” all’inizio della prima Intifada, e i suoi soldati non si erano tirati indietro. Oggi [nel 2003], si parla solo e semplicemente di deportare o uccidere in massa i proletari rinchiusi nei campi. L’ex generale Effi Eitam, nominato [all’epoca] ministro da Sharon, ha trovato l’idea del “trasferimento” politicamente “allettante”: secondo questo ex politico laburista, “non molti arabi rimarranno qui” in caso di guerra totale. Come ha sottolineato Sergio Yahni, “siamo ora testimoni di un dibattito intellettuale tra israeliani della peggior sorte: una discussione sulla possibile deportazione e sull’uccisione di massa dei palestinesi”. “Pulizia etnica”, “trasferimento”, “deportazione”, “apartheid”: sono queste le parole, sempre più spesso utilizzate, della soluzione finale che la borghesia internazionale sta preparando per i proletari in Palestina. Il capitalismo rimane capitalismo, qualunque sia il suo colore, fino alla caricatura: Gli ufficiali israeliani hanno recentemente preso l’iniziativa di tatuare dei numeri sulle braccia dei palestinesi arrestati.
In breve, i proletari israeliani ascoltano senza dubbio con meno credulità le favole raccontate dalla borghesia israeliana per mandare regolarmente loro e i loro figli al fronte. Il prezzo umano che devono pagare per difendere l’idea nazionale è sempre più in contrasto con l’orrore materiale della guerra.
Naturalmente, queste resistenze hanno ancora difficoltà a superare le barriere del pregiudizio nazionale. Come abbiamo visto, le reazioni sono poche e molto distanti tra loro, e sono ancora per lo più confinate a un punto di vista che oppone una politica “buona” a una politica “cattiva” per il Paese. Ma, pur non sottovalutando il pericolo rappresentato dall’assenza di un vero programma rivoluzionario, ci ostiniamo a difendere che queste illusioni ideologiche sono meno importanti degli eventi stessi: oggi in Israele i giovani proletari si rifiutano di prestare il servizio militare e affrontano con determinazione il disprezzo sociale di cui sono oggetto; i soldati di leva rendono pubbliche le ragioni per cui non vogliono più combattere; i soldati in pensione lanciano appelli per rifiutarsi di andare nei territori occupati; intere famiglie sostengono la scelta dei riservisti refrattari nonostante l’onere finanziario rappresentato dalla conseguente perdita di qualsiasi stipendio14.
L’odio per la guerra assume molte forme, dall’obiezione di coscienza al vero e proprio rifiuto, e al di là dell’inevitabile confusione insita in ogni abbozzo di resistenza al capitalismo e alla guerra, la realtà è lì: in uno spazio ideologicamente e militarmente controllato come Israele, i proletari tornano a proporre i loro interessi elementari – non morire – e si organizzano per difenderli.
La lettera inviata al “suo” generale da un giovane soldato israeliano che si rifiuta di combattere rivela in modo più esplicito questo punto di vista di classe e l’opposizione di interessi esistente tra generali borghesi e soldati proletari. Questa lettera, intitolata “La mia risposta al generale”, è un’altra testimonianza, anche se un po’ esitante, ma comunque molto interessante, di questo processo che, ovunque e in qualsiasi momento, porta i soldati, che sono gettati dai loro capi sulla strada dell’odio verso i proletari vicini, a guardare invece dalla parte degli emissari assassini, dalla parte dei patrioti, dalla parte dell’autorità militare.
Al generale che lo ha convocato nell’ottobre [2002] per “compiti operativi” nella Striscia di Gaza, il riservista Yigal Bronner ha risposto che sapeva che questa missione implicava l’obbedienza agli ordini, e che a un certo punto si sarebbe trovato in un carro armato di fronte a un ufficiale che a sua volta aveva obbedito a ordini superiori, e che gli avrebbe ordinato di sganciare una granata sui palestinesi. “Sono il mitragliere. Sono l’ultimo piccolo ingranaggio di questa sofisticata macchina da guerra. Sono l’ultimo e il più piccolo anello della catena di comando. Dovrei solo obbedire agli ordini. Ridurmi allo stimolo e alla risposta. Sentire il comando ‘Fuoco!’ e premere il grilletto. Per inciderlo nella coscienza di ogni palestinese. Completare la grande demarcazione. E fare tutto questo con la naturale semplicità di un robot che non percepisce nulla al di là dello scuotimento del carro armato mentre la granata viene espulsa dalla canna del fucile e vola verso il suo obiettivo. Ma ho un difetto, disse, parafrasando Brecht, sono un uomo e sono capace di pensare… Perciò devo rifiutare la vostra chiamata al servizio. Non verrò a premere il grilletto per conto vostro”. […]15
Come prezzo della sua franchezza, Yigal Bronner viene condannato a 28 giorni di prigione, durante i quali è sottoposto a incessanti maltrattamenti e umiliazioni. Lavora 14 ore al giorno nelle cucine di una caserma per giovani coscritti, gli viene proibito di parlare con gli altri prigionieri, gli vengono confiscati gli effetti personali, non ha cuscini o coperte su cui dormire e viene umiliato con l’obbligo di portare un cappello in testa per tutto il giorno16. Insomma, come tutti coloro che sono sottoposti a un’obbedienza imbecille, sopporta la solita vigliaccheria di tutti gli eserciti e di tutti gli Stati del mondo. Ma come tanti altri proletari in Palestina, in Israele o in altre parti del mondo, queste seccature stanno costruendo le determinazioni di domani, quelle che porteranno i rifiutanti israeliani di oggi a diventare i rivoluzionari internazionalisti di domani. E scommettiamo che quando lo faranno, il proletariato non risponderà più alla violenza dei generali solo con le lettere.
Non siamo né israeliani né palestinesi, né ebrei né musulmani… Siamo il proletariato!
Lo slogan che fa da titolo a questo articolo si ispira alla dura replica degli scioperanti inglesi ai loro sfruttatori che, durante la cosiddetta Prima Guerra Mondiale, li accusavano di essere complici del nemico: “Non siamo né inglesi né tedeschi, siamo il proletariato!”, risposero. In una situazione di guerra imperialista, questa precisazione politica, qui vigorosamente e orgogliosamente rinfacciata ai nazionalisti inglesi, rappresenta sempre un salto di qualità essenziale per lo sviluppo della rivoluzione, non solo perché questa dissociazione dall’unione nazionale contiene il confronto con la “propria” borghesia, ma anche perché rifiutando l’identità nazionale, alla quale il nemico di classe vuole incatenarli, i proletari promuovono contemporaneamente i legami naturali che li uniscono ai proletari delle altre nazioni. Questa è l’essenza del disfattismo rivoluzionario. Denunciare la “nostra” borghesia come nemico diretto e affrontarla (“noi non siamo inglesi…”), e allo stesso tempo affermarsi come classe rivoluzionaria (“noi siamo il proletariato…”) è uno stimolo fenomenale alla generalizzazione della lotta di classe, anche nel cosiddetto campo avverso.
Questa è anche che cosa è in gioco nelle rotture che potrebbero svilupparsi all’interno di questa unione nazionale così indispensabile allo Stato di Israele per continuare ad assumere il suo ruolo di cane da guardia in Medio Oriente. Gli attuali rifiuti di prestare servizio sono chiaramente imbarazzanti per lo Stato, ma se vogliono rimanere più che semplici “obiezioni di coscienza”, relativamente sopportabili e gestibili dallo Stato, devono necessariamente essere armati di una prospettiva sociale. Una prospettiva sociale che non risiede tanto nell’espansione obbligatoria del numero di refuseniks, ma nel vedere questi proletari definire apertamente il loro rifiuto dell’esercito come un vero e proprio scontro con il capitalismo, come uno scontro non solo con i ministri “corrotti” e i generali “cattivi”, ma con l’intero sistema che li ha prodotti, con la “propria” borghesia, con lo Stato nella sua interezza.
“Non siamo né israeliani…”: lo sfruttamento non conosce frontiere, non possiamo difendere i confini che delimitano il nostro sfruttamento; non abbiamo interessi comuni con la borghesia che ci sfrutta e ci manda a combattere; vogliamo la sconfitta dei “nostri” sfruttatori, della “nostra” borghesia, del “nostro Paese”, per abolire ogni sfruttamento e ogni confine…
“… né palestinese…”: lavorando per la sconfitta del capitalismo ovunque ci troviamo, incoraggiamo praticamente i proletari dell’altra parte a continuare e intensificare la loro lotta, chiamando i nostri fratelli e sorelle di classe nel campo nazionale opposto a riconoscersi come fratelli e sorelle di classe, a unirsi alle file di coloro che sono chiamati refuseniks, a disobbedire ai loro stessi ufficiali, a usare le nostre reti per disertare, a fraternizzare con noi, a usare i nostri spazi per sconfiggere insieme la “loro” borghesia…
“Noi siamo il proletariato!”: la nostra identità non è nazionale, è sociale; ma siamo molto di più degli operai edili di Gaza o di Tel Aviv, molto di più dei lanciatori di pietre palestinesi o dei refuseniks israeliani, molto di più delle categorie sociologiche in cui cercano di confinarci… come proletariato, siamo molto di più di una massa di sfruttati, siamo un progetto sociale rivoluzionario che mira ad abolire tutte le classi sociali, siamo il comunismo.
Senza dubbio il proletariato israeliano non è ancora in grado di sviluppare una pratica rivoluzionaria articolata intorno a formulazioni così audaci (non più di quanto lo sia oggi in Palestina o nel resto del mondo, peraltro), ma le poche rotture che abbiamo salutato in questo testo, per quanto isolate o confuse, testimoniano l’inevitabile sviluppo dell’opposizione ai progetti morbosi e barbarici dello Stato capitalista, e si impegnano in questo percorso.
Come abbiamo sottolineato, la forza di queste rotture sta nel fatto che nascono dall’interno, che si confrontano praticamente con il proprio esercito, il proprio Stato, le proprie ideologie, anche se la chiarezza programmatica è ancora drammaticamente carente, anche se le formulazioni sono maldestre, se non del tutto inadeguate. La strada della lotta di classe è segnata dallo sviluppo stesso della catastrofe capitalista, dall’incapacità del capitalismo di offrire altro che un aumento dello sfruttamento e della guerra. E queste determinazioni costringeranno il proletariato a riconoscersi più apertamente come soggetto rivoluzionario, ad andare oltre le contingenze nazionali, a sostenere esplicitamente il disfattismo rivoluzionario e ad affermare pienamente l’abolizione dello Stato come prospettiva.
Anche se socialmente non è ancora così, alcune minoranze stanno già cercando, controcorrente, di difendere alcuni aspetti di questa prospettiva. È il caso, ad esempio, di un volantino firmato “Ebrei contro il sionismo”, distribuito il 18 maggio 2002 a Londra durante una manifestazione di sinistra “per i diritti dei palestinesi”, in cui, anche in questo caso, gli “ebrei” denunciano i crimini del “loro” Stato, ma in una prospettiva più globale che collega all’abolizione di tutti gli Stati:
“Il sionismo è il risultato prevedibile del nazionalismo, del colonialismo e dello statalismo mondiale. Nato in un momento in cui il mondo veniva spaccato e il sistema degli Stati nazionali europei si consolidava, il sionismo è complice del potere occidentale e flagello dei palestinesi. L’alleanza del sionismo con il potere e la tirannia non lo rende il guardiano degli ebrei. Ha sempre collaborato con razzisti e assassini per favorire la colonizzazione della Palestina. Al contrario, sosteniamo coloro che cercano di rovesciare i “propri” governi e leader. Sosteniamo le lotte che hanno il potenziale per minare lo Stato e il capitalismo. (…) I fondatori del sionismo hanno rifiutato la possibilità di superare l’antisemitismo attraverso la lotta popolare e la rivoluzione sociale. (…) Il razzismo e l’oppressione dimostrati dallo Stato israeliano non sono insoliti. I tradimenti storici del sionismo non sono unici: sono comuni a tutte le forme di nazionalismo. Il nostro antisionismo si basa sull’opposizione a tutti gli Stati, a tutti i confini e a tutte le nazioni; a tutti i governanti e gli sfruttatori del mondo.
Per un’intifada globale e la fine di tutti i confini!”.17
I campi di battaglia permanenti creati dagli Stati israeliano e palestinese come spazio vitale, così come l’uso macabro del martirologio per alimentare i rispettivi bisogni di carne da cannone, spingono sempre più proletari a rompere con le rispettive religioni di Stato e a identificare il loro nemico comune. E questo nemico comune, in ogni momento, qualunque sia la nostra nazionalità, rimane il capitalismo, lo Stato che lo struttura, l’esercito che lo difende, la borghesia che lo incarna.
Di fronte a tutti coloro che cercano di ridurre le nostre rivolte anticapitaliste a un terreno nazionale, rivendichiamo a gran voce la bandiera del popolo senza Stato, la lotta degli oppressi, la prospettiva internazionale di una società senza classi.
Sviluppiamo le nostre organizzazioni indipendentemente dalle nostre nazionalità. Anzi, cerchiamo di fraternizzare, di entrare in contatto da entrambi i lati della frontiera e di sviluppare legami militanti che permettano ai proletari di entrambi i lati di sfuggire agli ufficiali, ai mullah o ai rabbini che cercano di reclutarli.
Sviluppiamo insieme la lotta contro la “nostra” borghesia! Giriamo le armi e opponiamoci a coloro che ci mandano in guerra per uccidere ed essere uccisi! Sviluppiamo il disfattismo rivoluzionario!
È sullo sfondo di questa lotta senza quartiere condotta dal proletariato in Palestina, e delle prime rotture dell’unione nazionale che si stanno verificando nello Stato di Israele, che proponiamo qui come “memoria operaia” un volantino del 1943 in cui i militanti rivoluzionari invitano i proletari “ebrei” a lottare contro la “propria” borghesia, rompendo così violentemente con l’antifascismo e lo stalinismo, che allora cercavano di descrivere ogni tedesco come un nemico.
“Non credete ai bugiardi nazionalisti. Gli operai tedeschi e italiani sono vittime come noi, sono nostri fratelli di classe”, dichiararono i militanti dei Comunisti Rivoluzionari, rivolgendosi agli “operai ebrei” in yiddish.
Ieri, oggi e domani, contro tutti coloro che cercano di dividerci, di deviare le nostre lotte, di trovare “differenze” nelle situazioni per meglio giustificare l’appartenenza a un determinato popolo (sia esso “eletto” o “martirizzato”), risponderemo, come gli autori del volantino: “i capitalisti sono uniti contro di noi, uniamoci contro i capitalisti!”.
Marzo 2003.
Volantino:
Lavoratori ebrei, compagni
Il Primo Maggio è il giorno del proletariato internazionale, il giorno della fraternizzazione proletaria. La nuova guerra mondiale è già in corso da quattro anni. È una guerra che non colpisce tanto i ricchi quanto i poveri. Siete perseguitati, maltrattati, sfruttati e sterminati.
Classe contro classe
Il capitalismo internazionale ha costantemente bisogno di nuova carne da cannone, di manodopera a basso costo. I lavoratori francesi, tedeschi, polacchi, italiani, cechi e di altri Paesi sono oppressi proprio come noi ebrei. In Africa, America, Russia, credenti o non credenti, latini, arabi, neri, gialli, bianchi, i lavoratori sono schiacciati dai loro stessi oppressori. In tutto il mondo, l’imperialismo ha rinchiuso i proletari in un enorme campo di concentramento.
Quanti ebrei capitalisti sono stati deportati? Neanche uno. Hanno tutti lasciato la Francia. E le masse di proletari ebrei stanno morendo, deportati in treni sigillati verso i campi di sterminio. Molti vivono in clandestinità, senza documenti né denaro, abbandonati dalla borghesia e dai burocrati ebrei.
Classe contro classe
Non un solo capitalista francese è stato deportato. Non un solo capitalista tedesco o italiano è caduto sul fronte orientale, non un solo capitalista angloamericano è morto nei deserti dell’Africa.
Tutti i proletari sono venduti e sfruttati dai loro capitalisti. Tutti gli schiavi sono nostri fratelli, tutti i capitalisti e tutti i traditori sono nostri nemici. Mai più popolo contro popolo, ma classe contro classe.
Nell’organizzazione Todt, tedeschi, ebrei e altri schiavi devono lavorare, oppressi dalle SS e talvolta sorvegliati da poliziotti ebrei. Le guardie mobili francesi perseguitano i lavoratori francesi. La Gestapo cerca disertori e rifugiati tedeschi. La GPU spara ai comunisti russi. La polizia britannica e americana opera contro gli scioperi in Inghilterra e in America.
Ma i lavoratori reagiscono
Ad Arcachon, quattrocento operai tedeschi e mille ebrei francesi scioperano per ottenere cibo migliore. Dieci tedeschi e venticinque ebrei furono fucilati, ma lo sciopero continuò. I tedeschi condivisero il cibo con gli ebrei, poiché le SS avevano vietato la distribuzione di cibo agli ebrei. I lavoratori francesi e stranieri si uniscono nella lotta contro la gendarmeria francese e tedesca.
I lavoratori tedeschi disertano, la resistenza passiva si diffonde in tutto il Paese. Ogni mese, migliaia e migliaia di uomini vengono fucilati. In tutto il mondo ci sono molti scioperi e lotte. La guerra imperialista si sta trasformando in una guerra civile contro i carnefici capitalisti.
Lavoratori ebrei, compagni, da che parte state?
Con la borghesia ebraica? Vi hanno sempre odiato e tradito. Traggono profitto dalla guerra mentre il vostro sangue scorre. Sono sempre uniti ai capitalisti non ebrei.
A che scopo i sionisti propongono un accordo con la borghesia ebraica per un “Paese ebraico”? Oggi anche Churchill, Roosevelt e Goebbels sono favorevoli a un Paese ebraico che sarebbe un nuovo campo di concentramento per le masse ebraiche. Grazie per tale Paese ebraico. La questione ebraica può essere risolta solo attraverso la fraternizzazione di tutti i lavoratori, attraverso la rivoluzione in tutto il mondo. Senza la vittoria della rivoluzione proletaria diffusa, gli ebrei saranno sempre sfruttati e perseguitati. Il vostro posto è con i proletari del mondo.
Il movimento sionista sta creando insediamenti e molti giovani vengono a viverci senza avere molte possibilità di vita per questi giovani. Dove vanno a finire i soldi per i giovani? La burocrazia della federazione UGIF si appropria di ogni responsabilità. Giovani ebrei, non lasciatevi sfruttare dai sionisti e dalla burocrazia ebraica.
Compagni
Pensate ai nostri morti. Pensate ai nostri fratelli nei campi che aspettano. Pensate ai vostri fratelli, alle vostre sorelle, ai vostri uomini e alle vostre donne, alle vostre fidanzate, ai vostri figli, ai vostri padri e alle vostre madri che sono nei campi con milioni di polacchi, cechi, russi, francesi e tedeschi, deportati all’inferno. Attendono la vostra azione per la loro liberazione.
Hanno capito che solo attraverso l’azione di tutti gli oppressi possiamo essere salvati. I nostri compagni sono caduti invano? Potete dimenticare i nostri fratelli nei campi di sterminio?
Non aspettatevi nulla da Roosevelt, Churchill o Stalin! Contate solo sulle vostre forze, sui proletari rivoluzionari di ogni paese.
Non credete ai bugiardi nazionalisti. I lavoratori tedeschi e italiani sono vittime come noi, sono nostri fratelli di classe. Per loro, come per noi, le SS sono il nemico principale.
I capitalisti sono uniti contro di noi, uniamoci contro di loro! Noi siamo i più forti, noi siamo le masse!
Abbasso la guerra imperialista!
Basta con il nazionalismo!
Basta con i pogrom, i massacri e le deportazioni!
Viva il 1° maggio, giorno della fraternizzazione proletaria internazionale!
Viva la nuova Internazionale dei lavoratori!
Avanti per la rivoluzione proletaria mondiale!
Pace! Libertà! Pane!
1° maggio 1943. Comunisti rivoluzionari.
Il volantino e i suoi autori: i “Comunisti Rivoluzionari”
Le tracce delle lezioni che i comunisti hanno imparato dalla nostra lotta storica sono rare e preziose. Anche la borghesia è consapevole del valore di questi materiali del passato e spende immense energie per oscurare la memoria della nostra classe, diffamare i nostri ex compagni, distorcere le loro lotte, distruggere la loro stampa…
È nel contesto della riappropriazione del nostro passato che presentiamo questo volantino firmato “Comunisti rivoluzionari” e distribuito il 1° maggio 1943, in piena guerra, nel sud della Francia.
Le poche informazioni che abbiamo su questo documento e sul gruppo che lo distribuì provengono da diverse fonti.
In primo luogo, abbiamo trovato la traduzione francese di questo volantino nel libro di Maurice Rajfus: L’an prochain la révolution. Les communistes juifs immigrés dans la tourmente stalinienne. 1930-1945 (Edizioni Mazarine, Parigi, 1985). [“L’anno prossimo la rivoluzione. I comunisti ebrei immigrati nella turbolenza stalinista”] Ecco l’unico commento dello storico:
“Al di là della terminologia e degli slogan modellati sul ‘Terzo periodo’ dell’Internazionale comunista, questo opuscolo è un documento notevole perché rompe con la fiducia assoluta che era opportuno accordare ai ‘grandi alleati’”.18
In secondo luogo, la nostra ricerca sulle tracce delle minoranze comuniste in questo periodo di frantumazione del proletariato ci ha portato a guardare più da vicino la traiettoria storica del gruppo che ha prodotto questo documento. Jüdische Arbeiter, Kameraden! è stato scritto, pubblicato e distribuito da militanti organizzati nel gruppo RKD, Revolutionäre Kommunisten Deutschlands.
La filiazione organizzativa e programmatica dei comunisti dell’Europa centrale che portò alla formazione della RKD è interessante e la riassumiamo qui.
Nel 1935, in Austria, diversi gruppi di militanti della Gioventù del KPÖ, Kommunistische Partei Österreichs, formarono una fazione che divenne sempre più apertamente critica nei confronti del partito stalinista, prima di staccarsi rapidamente e trasformarsi in un’organizzazione autonoma con il nome di RKÖ, Revolutionäre Kommunisten Österreichs. Nel 1936-37, la RKÖ pubblicò l’organo Bolschewik, il cui motto era: “Il nemico è nel nostro proprio Paese!”. La loro militanza fu un indiscutibile punto di riferimento per molti militanti che, come loro, erano in procinto di staccarsi dal movimento trotskista, tra cui il gruppo Bolschewiki-Leninisten. Dal 1937 al 1938, la RKÖ, fortemente critica nei confronti del movimento trotskista, affermò il proprio carattere internazionalista nella rivista Der Einzige Weg, pubblicata insieme a rivoluzionari svizzeri e cecoslovacchi.
Nel 1938, la repressione li costrinse all’esilio in Europa occidentale. Si avvicinarono alle posizioni della Revolutionary Workers League (RWL) negli Stati Uniti, che, in aperta opposizione alla corrente trotskista, era impegnata nel disfattismo rivoluzionario durante la lotta della nostra classe in Spagna. Pubblicarono una serie di opuscoli, gli Juniusbriefe.
Nel 1939 e nel 1940, ad Anversa, in Belgio, la RKÖ pubblicò la rivista Der Marxist e, in Francia, il Bulletin oppositionnel. Intorno al 1941, formarono un gruppo di rottura per alcuni militanti trotskisti tedeschi in esilio. Presero il nome di Revolutionäre Kommunisten Deutschlands (RKD) invece di RKÖ.
Nel 1941, la RKD aveva sede soprattutto nel sud della Francia, dove fu molto attiva, pubblicando regolarmente la propria stampa nonostante l’esilio, la clandestinità e la repressione: il RK-Bulletin, dal 1941 al 1943, e Spartakus, dal 1943 al 1945. Le analisi contenute nella loro stampa mostrano un rafforzamento delle posizioni internazionaliste. Oltre alla stampa periodica, tra il 1942 e il 1944 la RKD distribuì dieci volantini internazionalisti (in tedesco, yiddish, francese e italiano), in condizioni di estremo pericolo. Il numero di aprile 1945 di Spartakus contiene un “Appello dei comunisti rivoluzionari di Germania al proletariato tedesco”, di cui riportiamo qui alcuni forti stralci:
“Non dimenticate che è stato il capitalismo a portare Hitler al potere. È stato il capitalismo a provocare la nuova guerra mondiale… Nonostante le loro rivalità imperialiste, gli sfruttatori di tutti i Paesi sono uniti contro il ‘pericolo’ della rivoluzione proletaria, che, per loro, è un pericolo mortale…
I capitalisti alleati e russi accorrono in aiuto della borghesia tedesca contro il proletariato tedesco. I capitalisti russi, con Stalin a capo, stanno strangolando qualsiasi movimento rivoluzionario. Hanno già liquidato le conquiste proletarie e rivoluzionarie dell’ottobre 1917. I comunisti in Russia sono stati imprigionati e fucilati. Il proletariato è stato schiavizzato, proprio come nel nostro Paese.
È quindi logico che gli assassini di massa della rivoluzione russa stiano ora deportando i vostri padri e figli, i vostri mariti e fratelli, sottoponendoli ai lavori forzati. Vietano ai loro propri soldati di parlare con voi, vi diffamano come ‘nazisti’ perché temono e vogliono impedire a tutti i costi la fraternizzazione tra lavoratori tedeschi e russi.
D’altra parte, hanno fatto pace con alcuni capitalisti e nobili tedeschi, con il feldmaresciallo nazista Von Paulus. Si affidano ai capi nazisti e ai boia delle SS che hanno graziato. Secondo loro solo i proletari tedeschi e russi hanno il dovere di odiarsi e uccidersi a vicenda, mentre i capitalisti ingrassano: questa è la volontà di Hitler, Stalin, Churchill e Co.
I borghesi inglesi, americani e francesi non agiscono diversamente…”.
Affermare le posizioni comuniste significa anche distinguerci dai nostri nemici:
“Non siamo socialdemocratici, stalinisti o trotzkisti. Non siamo interessati al prestigio. Siamo comunisti, spartachisti rivoluzionari.”
Nel 1942, in Francia, si formarono i gruppi CR, Communistes révolutionnaires, che nel 1943 e nel 1944, nella rivista Fraternisation prolétarienne, difesero posizioni simili a quelle sviluppate dalla RKD.
Nonostante l’autonomia organizzativa che entrambi i gruppi hanno conservato, hanno comunque cercato di unire le forze e persino di centralizzare la loro attività contro il Capitale. Incontri, discussioni, dibattiti, ecc. sono stati organizzati congiuntamente, sempre clandestinamente. Insieme istituirono una commissione internazionale e pubblicarono un organo, L’Internationale.
Nel 1944 fu creata l’OCR, Organisation Communiste Révolutionnaire (“Organizzazione Comunista Rivoluzionaria”), che pubblicò due riviste – Rassemblement Communiste Révolutionnaire (“Riunione Comunista Rivoluzionaria”) e Pouvoir Ouvrier (“Potere Operaio”) – insieme ai CR. La RKD, insieme all’OCR, pubblicò la Vierte Kommunistische Internationale (“Quarta Internazionale Comunista”) nel 1944 e nel 1945. Quindi, durante gli anni ‘40, esisteva un ambiente rivoluzionario in cui questi tre gruppi: CR, OCR e RKD rafforzarono le loro posizioni programmatiche nel confronto/demarcazione con bordighisti, “anarchici”, “comunisti dei consigli” e trotskisti di sinistra.
Nel 1945, la repressione ebbe finalmente il sopravvento sui militanti della RKD, che si strutturarono contro e al di là delle frontiere, delle famiglie politiche, della repressione e dello scoraggiamento per affermare sempre più fortemente il nostro programma comunista.
Nonostante il prolungato isolamento e la repressione degli anni più bui della controrivoluzione, gli anni ‘30 e ‘40, questi tre gruppi di militanti comunisti hanno sviluppato l’attività di classe da una rottura all’altra. Hanno lavorato alla ricostruzione programmatica dopo la sconfitta dell’ondata di lotte del 1917-2319. E lo fecero resistendo a molte fazioni cosiddette comuniste impantanate nell’opposizione centrista (trotskista o bordighista), bloccate nella problematica del sostegno e della sottomissione alle politiche dell’URSS, che basava il suo dominio sulla sconfitta della rivoluzione e sulla restaurazione dell’“Internazionale Comunista”. Quest’ultima, incancrenita dalla controrivoluzione fin dall’inizio, divenne rapidamente una delle sue punte di diamante. In breve, i militanti organizzati all’interno di CR, OCR e RKD dovettero resistere al processo storico di controrivoluzione.
È in questo quadro e controcorrente che questi gruppi perseguirono:
- la necessaria valutazione delle lotte rivoluzionarie del 1917-23, che li portò ad assumere, attraverso le loro varie rotture, l’organizzazione del…
- … disfattismo rivoluzionario, in particolare attraverso la pubblicazione, in diverse lingue e in diversi paesi, di appelli per lo sviluppo e l’unificazione della lotta contro la guerra, includendo chiare denunce della solidarietà di tutte le fazioni borghesi e di tutti i paesi contro il proletariato, e proponendo motti organizzativi corrispondenti agli interessi unici e mondiali del proletariato.
- il raggruppamento e la centralizzazione internazionale delle forze rivoluzionarie.
Contro lo stalinismo, allora ultra-dominante, migliaia di proletari si rivolsero al trotskismo per strutturare la loro lotta contro la borghesia. Mentre il trotskismo difendeva in generale il programma riformista della borghesia, la corrente trotskista in questo periodo raccoglieva anche un gran numero di proletari combattivi che avevano parzialmente rotto con lo stalinismo (l’esperienza della rivoluzione e della controrivoluzione in Spagna è preziosa a questo proposito) cercando di imporre loro la politica suicida e controrivoluzionaria del suo “sostegno critico”. Il movimento comunista, attraversando l’intera società borghese, si esprimerà allora in quelle minoranze che non si fermano alla pseudo-rottura trotskista, ma rompono anche con il trotskismo stesso, che denunciano come espressione centrista, come parte della controrivoluzione, e su questa base affermano posizioni classiste e internazionaliste invarianti e intransigenti. La RKD è un esempio di questa corrente comunista. Inizialmente organizzati all’interno della sinistra dell’opposizione trotskista, questi comunisti rivoluzionari erano portatori di posizioni rivoluzionarie, in totale rottura con la corrente trotskista. La forza e la chiarezza della loro rottura con i trotskisti, così come quella della CR e della futura OCR, risiedeva nella necessità di prendere una posizione chiara sulla guerra, di mettere in discussione la propria traiettoria e di trarne insegnamenti programmatici.
I compagni della RKD che firmano il volantino che invita alla solidarietà proletaria e al disfattismo rivoluzionario contro tutti gli schieramenti borghesi fanno quindi parte di questa piccola minoranza di militanti che, di rottura in rottura, è emersa come una delle poche organizzazioni militanti ad affermare il disfattismo rivoluzionario come materializzazione viva dell’internazionalismo proletario. I militanti attuali e futuri hanno molto da imparare dalle loro attività. Per questo motivo la ripubblicazione di questo documento è di grande importanza, per una serie di ragioni.
Sebbene sia indirizzato ai proletari “ebrei”, che all’epoca si esprimevano soprattutto in yiddish, è uno dei pochi documenti che supera e critica la specificità ebraica. Definirsi pro o antiebraico, pro o antisionista, pro o anti-Israele… è sempre un atteggiamento razzista e controrivoluzionario. Significa sottomettersi alla polarizzazione borghese. Il paragrafo seguente del volantino è così chiaro e sovversivo che conserva tutta la sua forza ancora oggi:
“Lavoratori ebrei, compagni, da che parte state?
Con la borghesia ebraica? Vi hanno sempre odiato e tradito. Traggono profitto dalla guerra mentre il vostro sangue scorre. Sono sempre uniti ai capitalisti non ebrei”.
Il proletariato non è né ebreo, né tedesco, né francese, né americano, né cinese. È una classe mondiale con interessi identici: la rivoluzione comunista per l’avvento di una società umana. È una classe che subisce lo stesso sfruttamento perpetrato da un’unica classe mondiale, la borghesia. Questa borghesia si sta scomponendo in mille sfaccettature… in competizione sul mercato del nostro sfruttamento, ma fondamentalmente ha gli stessi interessi ovunque: la perpetuazione del capitalismo. Portare alla ribalta questa realtà nel 1943 è un’affermazione potente da sottolineare.
Denunciare l’ideologia del “popolo ebraico” è importante per una serie di ragioni. L’ideologia della persecuzione ebraica è stata molto strutturante durante e soprattutto dopo la guerra, in relazione a due assi:
- creare una giustificazione per la costituzione di uno Stato-Gendarmeria ebraico in Medio Oriente;
- creare/rinforzare la polarizzazione borghese fascismo/antifascismo. Questa polarizzazione intrappola ancora molte reazioni proletarie su questo terreno borghese. È una carta che la borghesia non ha ancora esaurito.
Solo le posizioni di classe possono permettere ai comunisti di superare e negare questo guazzabuglio storico-sociologico-religioso antiproletario della specificità ebraica.
Scegliere di ripubblicare oggi questo opuscolo significa anche prendere parte all’invariabile difesa della posizione storica dei comunisti sull’internazionalismo. Questo volantino si colloca chiaramente sul nostro terreno di lotta di classe contro le nazioni e le patrie… contro il capitale e tutte le sue guerre. Lo slogan: “Mai più popolo contro popolo, ma classe contro classe”, è un motto comunista. Gli stalinisti lo hanno dirottato e utilizzato per confondere ulteriormente il proletariato. La frazione borghese stalinista ha promosso il razzismo e il nazionalismo sotto la maschera dell’antinazismo… come ha fatto il poeta stalinista Ilya Ehrenburg, che per tutta la guerra ha scritto sconce esortazioni all’omicidio e allo stupro:
“Uccidere! Uccidere! Nella razza tedesca non c’è altro che il male; non uno tra i vivi, non uno tra i non ancora nati non è malvagio! Seguite i precetti del compagno Stalin. Eliminate la bestia fascista una volta per tutte nella sua tana! Usate la forza e spezzate l’orgoglio razziale di queste donne tedesche. Prendetele come vostro legittimo bottino. Uccidete! Uccidete, voi valorosi soldati dell’Armata Rossa, mentre vi lanciate all’assalto”.
La riappropriazione dello slogan “Mai più popolo contro popolo, ma classe contro classe” da parte di questi militanti della RKD nel 1943, non è quindi solo, come ha insinuato lo storico Rajfus, un “motto modellato sul ‘Terzo Periodo’ dell’Internazionale Comunista”, ma un’espressione della lotta del proletariato, che cerca di imporre la sua lotta sul suo stesso terreno, l’internazionalismo!
Il proletariato è stato distrutto dalla polarizzazione fascista/antifascista. Decine di milioni di proletari hanno servito (e sono stati inghiottiti) sotto le bandiere del fascismo, ma anche dell’antifascismo stalinista, socialdemocratico, “anarchico”, cristiano e di altre forme. Dalla sconfitta della rivoluzione (1923 circa), questa polarizzazione ha spianato la strada alla distruzione massiccia del proletariato nel 1938-45.
La corrente della RKD ha tentato di perpetuare l’eredità programmatica dei comunisti dell’ondata di lotte del 1917-23. Per illustrare il nostro punto di vista, citiamo un appello dei makhnovisti del maggio 1919. Questo appello faceva parte della lotta intransigente dei nostri compagni in Ucraina contro i pogrom contro gli ebrei e per la lotta internazionalista:
“Dobbiamo proclamare ovunque che i nostri nemici sono sfruttatori e oppressori di varie nazionalità: il fabbricante russo, il magnate del ferro tedesco, il banchiere ebreo, l’aristocratico polacco… La borghesia di tutti i Paesi e di tutte le nazionalità è unita in un’aspra lotta contro la rivoluzione, contro le masse lavoratrici di tutto il mondo e di tutte le nazionalità”.
Peter Arshinov, “Storia del Movimento Makhnovista”, 1921
Pur sottolineando i punti di forza di questo volantino, dobbiamo ammettere che ci sono anche confusioni o debolezze che dobbiamo superare attraverso l’arma della critica per rafforzare le rotture militanti della nostra classe. Per cominciare, mettiamo in evidenza questa: “Per loro, come per noi, le SS sono il nemico principale”. Il nostro principale nemico, il nostro unico nemico, è il capitale e tutte le fazioni concorrenti che lo sostengono. In Francia, non sono state le SS, ma la polizia e la gendarmeria francese a portare avanti la maggior parte della repressione durante gli anni della guerra. Queste forze armate borghesi furono ulteriormente aiutate dagli stalinisti, che uccisero alcuni dei nostri compagni o li denunciarono alla Gestapo. L’ideologia del nemico principale implica l’esistenza di nemici secondari, e quindi di risposte proletarie distinte in ciascun caso, il che equivale a definire un programma minimo di resistenza e un programma massimo per il dopo rivoluzione.
Contro questa ideologia di nemici principali e secondari, il proletariato ha fatto valere il motto: “Il nemico è nel nostro stesso Paese, è la nostra stessa borghesia!”. La posizione dei rivoluzionari contro la guerra capitalista è sempre la stessa: opporre la rivoluzione sociale alla guerra, combattere contro la “propria” borghesia e il “proprio” Stato nazionale. Storicamente, questa posizione è stata chiamata disfattismo rivoluzionario, perché proclama apertamente che il proletariato deve combattere il nemico che ha di fronte nel “proprio” Paese, che deve agire per portarlo alla sconfitta e che solo in questo modo può partecipare all’unificazione rivoluzionaria del proletariato mondiale, solo in questo modo la rivoluzione proletaria può svilupparsi in tutto il mondo.
C’è un’altra posizione nel volantino che riteniamo problematica, ed è il motto finale “Pace!”. Di che tipo di pace stiamo parlando? Non c’è pace in sé. La borghesia impone la pace sociale attraverso il massacro generalizzato dei proletari e la distruzione delle nostre forze di classe. Sappiamo che la pace del capitale è la continuazione della sua guerra contro i nostri interessi, le nostre stesse vite e il nostro progetto sociale di rivoluzione. Per fermare i massacri e le deportazioni, il proletariato deve intensificare la sua guerra di classe, rivoluzionare il mondo e abbattere il potere del denaro e del terrore incarnato dalla borghesia. Contro il terrore della borghesia, il proletariato è costretto a usare il suo terrore di classe. Ma storicamente combatte per l’abolizione di tutto il terrore, di tutti gli Stati.
In generale, “pane, pace e libertà” è un motto socialdemocratico. Ma mentre la borghesia si nasconde dietro il motto “pace”, gli interessi proletari si sono storicamente espressi con il motto “pane e libertà”. In molti Paesi, le lotte proletarie hanno spesso sventolato questa bandiera. Nello sforzo storico di chiarire il nostro programma rivoluzionario, è fondamentale distinguerci chiaramente dai nostri nemici e opporci alla loro demagogia politica e disorganizzante con motti precisi che diano una direzione alla nostra lotta.
In un momento di totale schiacciamento di questa ondata rivoluzionaria, nel mezzo di un periodo di intenso terrore bianco, i nostri compagni della RKD ci hanno dimostrato che il proletariato, negli anni di guerra 1939-45, stava ancora rilanciando la sfida comunista contro il mondo borghese.
L’espressione dell’avanguardia comunista, da parte di questo gruppo di “comunisti rivoluzionari”, lontani dallo scoraggiarsi e dall’abbandonare la lotta, dà chiare prospettive alla nostra lotta storica, che sono valide ancora oggi. Sebbene questo periodo sia stato generalmente di sconfitta e schiacciamento per il proletariato, si possono trovare tracce della lotta comunista ultra-minoritaria nel corso degli anni.
Compagni, se avete ulteriori informazioni su questo gruppo e in generale su qualsiasi espressione della nostra lotta durante e dopo il periodo 1939-45, fatecelo sapere.
Contro l’amnesia con cui la borghesia vorrebbe colpirci, partecipiamo alla riappropriazione della nostra memoria di classe!
Traduzione italiana: Gli Amici della Guerra di Classe
1 “Intifada” in arabo significa insorgere.
2 È davanti al rinnovato centro di Gaza che giornalisti e delegazioni di diplomatici in estasi vengono ad applaudire il dinamismo della regione. Ed è proprio qui che sono finite le donazioni internazionali, dove si concentrano le istituzioni e gli alti funzionari.
3 Diciamo “parzialmente rovinata” perché le storie d’amore tra Stati non finiscono mai quando si tratta di reprimere il proletariato. Ad esempio, la guerra tra lo Stato di Israele e quello di Palestina non impedisce in alcun modo la loro collaborazione e, dopo l’11 settembre, lo Stato palestinese non si è fatto scrupolo di acquistare armi da Israele per reprimere i gruppi che avevano espresso il loro consenso agli attentati di New York. Da parte sua, lo Stato di Israele non ha esitato ad armare lo Stato palestinese. Quando si tratta di reprimere il proletariato, lo Stato borghese mostra apertamente il suo volto sovranazionale.
4 Naturalmente, non ci riferiamo alle bande islamiste che abbiamo appena denunciato, che sfruttano a sangue freddo la disperazione che regna nei campi per trasformare i poveri disgraziati che anestetizzano con il loro oppio religioso in carne da cannone, in “assassini di ebrei o atei”.
5 Il 99% del sostegno dato dalla borghesia nordamericana allo Stato di Israele è avvenuto dopo il 1967, cioè dopo che Israele aveva dimostrato di essere una potenza regionale vincendo la Guerra dei Sei Giorni. Oggi questo sostegno è giustificato dal “dovere storico di difendere Israele” e si riferisce esplicitamente al “diritto degli ebrei ad avere una terra”. Ma il governo nordamericano si guarda bene dallo spiegare perché Israele non abbia ricevuto lo stesso sostegno tra il 1948 e il 1967, in un momento in cui era molto più vulnerabile. Le vie dell’ipocrisia sono infinite.
6 “Israele riceve di solito circa un terzo dell’intero bilancio degli aiuti esteri, nonostante il fatto che Israele rappresenti meno dello 0,001 della popolazione mondiale… In altre parole, Israele, un Paese di circa 6 milioni di persone, riceve attualmente più aiuti dagli Stati Uniti di tutta l’Africa, l’America Latina e i Caraibi messi insieme, se si escludono Egitto e Colombia”. La maggior parte di queste informazioni e cifre sono tratte da “U.S. Aid: The Lifeblood of Occupation”, Matt Bowles in Left Turn #4, marzo-aprile 2002. [vedi articolo completo qui: https://www.wrmea.org/congress-u.s.-aid-to-israel/us-aid-the-lifeblood-of-occupation.html]
7 Alla fine di una guerra, i vincitori non solo impongono le loro condizioni economiche e politiche agli sconfitti, ma dettano anche il quadro ideologico entro il quale la loro vittoria deve essere d’ora in poi giustificata e la storia “pensata”. Così, i vincitori del 1940-45 non esitarono a riformulare le loro conquiste nella guerra imperialista come una grande battaglia “antifascista” condotta per liberare il mondo dall’antisemitismo nazista e dai campi di concentramento. Per far passare questa versione, era ovviamente necessario mettere da parte gli aspetti che contrastavano con questa verità: le numerose alleanze strette con i nazisti prima della guerra (compreso il patto Hitler-Stalin), il rifiuto degli Stati “antifascisti” di accogliere gli ebrei di cui la Germania voleva sbarazzarsi, l’esistenza di campi di concentramento negli Stati Uniti, in Inghilterra e in Francia, il sostegno di Winston Churchill ai massacri di Mussolini in Abissinia, l’aperta collaborazione degli Stati occidentali alle deportazioni di ebrei in Germania, e così via.
8 Estratto da “Lettera da Israele” di Ran HaCohen, le cui reazioni possono essere lette in inglese sul suo sito web (http://www.antiwar.com/hacohen/). “La logica di Auschwitz” è stata scritta nel marzo 2002, in seguito al clamore suscitato dall’audace paragone tra i campi nazisti e la situazione nei territori occupati, fatto dallo scrittore portoghese José Saramango in occasione della sua visita a Ramallah come parte di una delegazione del “Parlamento internazionale degli scrittori” (IPW). [vedi articolo completo qui: https://original.antiwar.com/hacohen/2002/04/01/the-auschwitz-logic/]
9 Basta vedere la crudezza con cui è stata squalificata l’ultima ondata di astensioni in Francia [nel 2002]: cifre reali nascoste, non votanti assimilati ai nazisti, caccia ideologica agli astensionisti… Accusati di essere nemici della Patria, della Repubblica e della Democrazia, tutti i non votanti sono stati costretti a fare un mea culpa e a impegnarsi pubblicamente a votare al secondo turno. L’inquisizione democratica esiste, e gli astensionisti l’hanno incontrata!
10 Il nipote dell’ex Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è registrato come obiettore di coscienza, dichiarando pubblicamente il suo rifiuto di prestare servizio nei territori occupati. La parentela con Netanyahu ha permesso di dare un po’ più di pubblicità al suo caso, ma questo non ha impedito all’esercito israeliano di mandarlo in prigione per diversi mesi.
11 L’Alternative Information Center (AIC) riunisce attivisti israeliani e palestinesi che lottano contro l’occupazione israeliana. Diversi di loro sono stati perseguiti in diverse occasioni per le loro attività. [Nel 2016, l’AIC è stato sciolto da un tribunale per “attività illegali”; tre anni dopo si è ricostituito come AIC-Palestina, stabilendo la propria sede nei territori amministrati dall’Autorità Palestinese].
12 [Vedi il testo completo qui: https://wri-irg.org/en/news/2003/yahni.htm]
13 Un rapporto pubblicato dal quotidiano Yedioth Ahronoth evidenzia lo sconcertante aumento di ansia e disturbi emotivi tra i giovani in Israele. Nel 2001, più di mille giovani hanno tentato il suicidio, tra cui oltre un centinaio di bambini tra gli 8 e i 12 anni. Queste cifre rappresentano un aumento del 10% rispetto all’anno precedente. Intanto, “a proposito del divario tra ricchi e poveri, un rapporto presentato in questi giorni alla Knesset rivela che Israele è il secondo Paese occidentale al mondo, dopo gli Stati Uniti, in termini di disparità di reddito”. La Repubblica, 4 dicembre 2002.
14 I soldati che si rifiutano di combattere, e quindi vengono messi in prigione, non ricevono più il salario del loro lavoro regolare, a differenza di quelli che accettano di prestare servizio. Questa minaccia al salario è ovviamente un enorme ostacolo materiale messo in atto dallo Stato per dissuadere i proletari dall’aderire al campo dei refusenik.
15 [Vedi il testo completo qui: https://wri-irg.org/en/news/htdocs/31102002a.html]
16 Ma non si perse d’animo. In una lettera affermava che: “Non c’è dubbio che sia meglio stare in prigione, isolati, con un cappello, in silenzio, a lavare i piatti e a sbucciare le cipolle. Preferisco – di gran lunga – versare lacrime quando taglio un sacchetto di cipolle dopo l’altro rispetto alle lacrime che sorgono ogni volta che evoco immagini dell’occupazione”.
17 Gli stessi autori denunciano come “di sinistra” la manifestazione “per i diritti dei palestinesi” durante la quale hanno distribuito questo volantino. Si sono uniti ad “altri facinorosi anticapitalisti” per guidare la manifestazione sotto uno striscione che proclamava “Ebrei contro il sionismo… e contro tutti gli Stati”. Al di là delle critiche che vanno fatte a questo volantino (non propone esplicitamente il proletariato come soggetto rivoluzionario e, anche se lo si vuole mettere in discussione, rimane troppo sul terreno delle categorie borghesi: i palestinesi, gli ebrei), se lo pubblichiamo è anche perché la religione di Stato israeliana è qui attaccata da proletari che si suppone siano sottomessi a questa ideologia, il che dà ancora più forza alle posizioni in esso difese. Si obietterà che il proletariato non ha patria e che quindi non c’è motivo, a priori, di fare riferimento esplicito ai Paesi o alle culture di origine di questi militanti che chiedono la distruzione dello Stato. Ma la contraddizione è solo apparente, perché questi compagni non firmano come cittadini israeliani, ma come antinazionali, come nemici della nazione israeliana e di tutte le nazioni, di tutti i nazionalismi. Questa è la dinamica del disfattismo rivoluzionario. In ultima analisi, è proprio la distanza percorsa tra l’origine degli autori (religione ebraica o nazionalità israeliana) e il loro obiettivo (contro tutti gli Stati, tutti i nazionalismi) a rendere il loro approccio più profondamente internazionalista, piuttosto che un appello opportunistico o platonico. Per dirla in altri termini, sventolare uno striscione in Israele che recita “Abbasso lo Stato di Israele, abbasso tutti gli Stati” ha un impatto politico molto maggiore dello stesso striscione in Palestina. [Leggi il testo completo: http://troploin0.free.fr/biblio/zajaz/]
18 L’imbarazzante riferimento dell’autore al “Terzo Periodo” dell’Internazionale Comunista per qualificare le affermazioni “classe contro classe” dell’opuscolo qui presentato, denota una precisa influenza della critica trotskista o democratica allo stalinismo. In realtà, l’IC ha recuperato solo opportunisticamente e momentaneamente motti che sono sempre appartenuti al proletariato, ed è assolutamente controrivoluzionario assimilarli ora alle frazioni borghesi che li hanno utilizzati. Così, la denuncia della socialdemocrazia come partito borghese o l’appello alla lotta di classe contro classe fanno parte delle affermazioni e delle rotture storiche del proletariato. Il fatto che lo stalinismo abbia momentaneamente utilizzato questi slogan per i propri traffici borghesi nei cambi di alleanze e nei riallineamenti non invalida in alcun modo queste posizioni.
19 Il testo dell’OCR “Rivoluzione e controrivoluzione in Russia”, apparso su Le Prolétaire nel 1946, è un contributo inestimabile alla comprensione del processo di riappropriazione programmatica da parte del proletariato in Russia durante l’ondata di lotta del ‘17-‘23, un periodo segnato dalle più grandi imprese di lotta e dalla mancanza di rottura che ne spiegano le tragiche conseguenze. Questo testo costituisce una tappa fondamentale nella critica internazionalista, classista e militante di questa enorme e terribile esperienza di confronto rivoluzionario per la nostra classe.