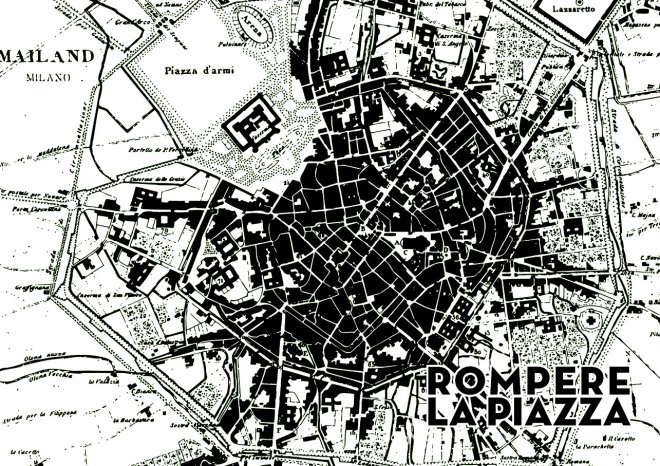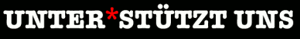“Uno sguardo sulla privatizzazione delle carceri in Italia” è un documento dalla rete che analizza in modo esatto il tema della privatizzazione delle carceri.
Introduzione
La privatizzazione delle carceri è un fenomeno oramai diffuso su tutti i continenti. Si è scritto e indagato tanto sulle sue origini, la sua storia e sui mostruosi effetti che si verificano nei contesti in cui si sviluppa. In paesi come gli Stati Uniti, l’Australia o la Gran Bretagna le prigioni private rappresentano da più di trent’anni una triste normalità e le grandi corporation che vi operano, hanno modellato i penitenziari statali secondo l’ottica liberista, riuscendo a capitalizzare, con precisione e a fondo, ogni aspetto della vita carceraria. Un processo che, mettendo a profitto la funzione base del carcere, quella detentiva e repressiva e sfruttando il lavoro, coatto o meno, dei detenuti è andato insomma ben oltre la semplice esternalizzazione del servizio lavanderia.
In molti luoghi, infatti, le carceri, in questo caso sia pubbliche che private, riforniscono una fetta non indifferente del mercato del lavoro, attraverso la fornitura di migliaia di detenuti -lavoratori a salario ridotto, un esercito di uomini e donne impegnati nei diversi comparti della sottofiliera industriale e agricola; manodopera a bassissimo costo capace di produrre lauti profitti per le imprese coinvolte. Molte volte gli stessi impianti di lavorazione sono presenti addirittura all’interno dei penitenziari. Ciò che si va a creare è un arcipelago di carceri – fabbrica, disseminati sul territorio nazionale, connessi con i gangli commerciali principali di un territorio. La messa a valore dell’universo carcerario nel caso delle carceri private, però, non si riduce prettamente al profitto assorbito dal lavoro dei detenuti, infatti, l’elemento cardine di tale fenomeno è rappresentato proprio dalla reclusione stessa, dall’internamento come produttore di plusvalore. In questo caso il carcere privato è definibile come una vera e propria fabbrica della reclusione, dove la presenza effettiva del prigioniero è di per sé fonte di guadagno e dove, quindi, è interesse dell’impresa- carceriere tenere costantemente piene le celle, assicurarsi, cioè, un flusso costante in entrata per garantirsi tariffe giornaliere o rimborsi dei costi. E’ facile immaginare quali siano le conseguenze sociali di un sistema come questo, i cui principi animano, d’altronde, anche la gestione dei Centri d’identificazione ed espulsione in Italia.
L’intero processo di privatizzazione segue svariate vie, assume forme differenti e si sviluppa lungo fasi nello specifico anche molto diverse tra loro, il più delle volte però è sorretto da un discorso politico emergenziale simile, correlato al secolare problema del sovraffollamento o giustificato dal sicuro risparmio per le casse dello Stato in un momento di recessione.
Cosa succede in Italia? Alla luce di quanto è in opera in altre parti del mondo, il sistema italiano, la cui privatizzazione è ancora agli albori, necessita di un approfondimento ulteriore, allo scopo di comprendere meglio le sue possibili evoluzioni ed essere in grado di sviluppare prospettive di lotta adatte a questo contesto in piena trasformazione.
Questo testo, cercherà di offrire un piccolo scorcio, breve e limitato al contesto nostrano, su alcuni aspetti particolari del fenomeno sopra citato.
Un processo lungo un ventennio
Negli anni ’90, sulla lunga scia delle politiche in atto in Gran Bretagna e Stati Uniti, venne avviato un programma generale di modernizzazione della pubblica amministrazione in un’ottica di razionalizzazione e trasformazione di tutti i suoi comparti e settori. Venne coniato così il termine di “New public management”, dottrina imposta allo scopo di rendere più efficiente il sistema pubblico, riducendone i costi e aumentandone i profitti, utilizzando modalità e metodologie proprie del settore privato.
In quel momento presero il via le prime esternalizzazioni del settore pubblico italiano, carceri comprese, e si decretò il cosiddetto “arretramento dello Stato”, in linea con le richieste generali d’imponenti istituzioni sovranazionali come FM, BM e Ocse.
Tale processo si inserì per di più nella cornice dei vincoli dettati dal trattato di Maastricht. Sebbene già dalla fine degli anni ’80 alcune aziende fossero entrate nel settore pubblico, ivi compresi i penitenziari, offrendo alcuni servizi come la pulizia delle strutture, solo dagli anni ’90 il fenomeno iniziò a diventare una procedura regolare nella fornitura di prestazioni delle più svariate.
Nel 2001 l’allora guardasigilli Fassino, nell’intento di proseguire verso la direzione di privatizzazione oramai avviata, dispose la dismissione di 21 carceri e l’individuazione di un modello inedito di prigione di media sicurezza e a trattamento penitenziario qualificato. Vennero create imprese apposite con l’intento di riconvertire le carceri considerate vetuste e, attraverso il coinvolgimento dei privati, individuare nuove aree edificabili per nuovi e moderni penitenziari. Benché i primi passi in tale direzione risultarono allora macchinosi e infine poco produttivi, le intenzioni rimasero comunque in piedi, addirittura rafforzandosi sotto la guida di Castelli.
Proprio in quegli anni, sotto la spinta di una politica repressiva senza precedenti nei confronti dell’utilizzo di sostanze stupefacenti, vide la luce quello che molti definirono il primo carcere privato in Italia. Il 21 Marzo 2005, dopo quattro anni dalla presentazione del progetto, nacque, infatti, a Castelfranco Emilia in provincia di Modena, la cosiddetta “Comunità agricola”, un comunità terapeutica di stato per la reclusione e il recupero di 140 detenuti tossicodipendenti. La gestione della struttura andò in mano, senza gara d’appalto, alla famigerata Comunità di San Patrignano. Al di là delle proteste che scaturirono per la scelta dell’associazione di Muccioli, famosa per le pratiche terapeutiche a dir poco ributtanti e violente, e al di là delle critiche per le politiche repressive che l’allora governo stava attuando, l’attenzione si concentrò, in parte, sulle modalità gestionali stesse, che mai avevano visto dei precedenti in Italia. Un ente privato, nello specifico un’associazione, prese in gestione tutte le mansioni e prestazioni, salvo quelle più schiettamente repressive e custodiali, di un vero e proprio carcere per detenuti tossicodipendenti. In questo caso non si parlò, infatti, di semplice esternalizzazione di uno o più servizi nell’ottica di un protocollo d’intesa, ma di una perfetta partnership pubblico-privato.
A piccoli passi
Nel 2012 sotto il Governo Monti venne emanato il Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, meglio conosciuto con il nome di “Decreto Liberalizzazioni”. Uno degli elementi più rilevanti di tale testo è contenuto nel Titolo II Capo 1, art. 43, in cui si affrontano importanti novità riguardanti l’edilizia carceraria. Intese come disposizioni urgenti per “fronteggiare la grave situazione di emergenza conseguente all’eccessivo affollamento delle carceri” si introdusse, questa volta in modo più concreto di quanto avesse fatto il governo di Centro-sinistra nel 2001, lo strumento del Project financing applicato al business della reclusione.
Ebbene che cos’è questo strumento? Il Project Financing è un dispositivo economico, già in uso in Francia e Gran Bretagna da molto tempo, che permette la partecipazione di grosse aziende, imprese private o Banche (quest’ultime solo se finanziano almeno il 20% del costo d’investimento) alla progettazione, costruzione e infine gestione di nuovi penitenziari. Infatti, lo Stato che partecipa con una percentuale al finanziamento, permette all’azienda che ha progettato e costruito il penitenziario di gestire la struttura in tutti i suoi servizi e mansioni, escluso quello custodiale, per 20 anni, ricavandone tutti gli utili e i profitti del caso. Allo scadere del ventennio la gestione ripassa, debiti compresi, allo Stato.
Una volta iniettata la riforma, il processo non tardò certo ad avviarsi.
Ai giorni nostri, qualcuno, come meravigliarsi d’altronde, ha colto la palla al balzo.
Il carcere di Bolzano
L’inaugurazione del nuovo carcere di Bolzano si sarebbe dovuta tenere nel giugno 2016, ma a causa di alcuni ritardi nei lavori, è slittata a giugno 2018. Questa struttura, voluta fortemente dalla provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, è definibile a tutti gli effetti come un vero e proprio penitenziario privato, il primo di questo genere in Italia. Il carcere – progettato per 220 detenuti e comprendente una sezione di 20 posti per semiliberi, una caserma per 30 agenti e moduli abitativi esterni per un centinaio di famiglie di secondini – è il primo esempio in Italia di partnership pubblico-privato applicata alla reclusione ed il primo caso di project financing riferito all’edilizia carceraria. Sarà una “rivoluzione trattamentale” secondo le parole dell’Avv. Massimo Ricchi, professore alla LUISS e consulente PPP per la provincia di Bolzano, in grado di andare incontro ad un sistema penitenziario che “come tutti i processi produttivi, (…) crea delle diseconomie e delle esternalità”. I punti forti del Project Financing sono la velocità nei tempi di attuazione, risparmi nella spesa per lo stato, possibilità di negoziazione con l’affidatario scelto per il progetto; elementi che creano un modello giuridico, tecnico ed economico- finanziario ripetibile.
È interessante notare come la possibilità di realizzazione di questa struttura sia stata permessa dapprincipio da una normativa emergenziale, decretata nel 2010 a causa del sovraffollamento carcerario, che ha consentito al Capo del DAP di ricoprire anche il ruolo di Commissario governativo per l’emergenza carceraria e quindi di essere al tempo stesso anche Commissario delegato con poteri emergenziali di protezione civile. Tale situazione, nel caso d’Intesa tra Governatore della regione o della provincia autonoma e il capo del Dap, ha permesso la concentrazione in un unico atto di tutti i punti della localizzazione, rendendo così il procedimento più veloce e derogando alle norme del codice civile e al codice dei Contratti. Quindi un contesto emergenziale che una volta annunciato, come spesso accade, permette al legislatore stravolgimenti giuridici e burocratici difficili da far passare in una situazione normale.
In linea generale, l’appalto ideato prevede la concessione di lavori pubblici in primo luogo per la progettazione e la costruzione della nuova prigione che, secondo lo studio di fattibilità, ammontano a circa 72 ml di euro, e in seconda battuta riguarda la gestione dello stesso per i vent’anni successivi. Più precisamente, da un lato, all’impresa vincitrice del bando spetta una parte del finanziamento della struttura, della sua progettazione definitiva ed esecutiva, secondo le linee guida progettuali, della sua costruzione, della fornitura di arredi, apparecchiature, attrezzature e suppellettili, dall’altro lato, secondo un profilo prettamente gestionale, l’impresa privata si farà carico della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile e degli impianti, della gestione delle utenze, del servizio lavanderia, della mensa collettiva e dello spaccio alimentare, del bar interno, della pulizia dell’edificio e della gestione delle attività sportive e di quelle formativo- ricreative. Questo carcere si presenta come un esempio innovativo, un modello di carcerazione al passo coi tempi, moderno nei metodi e nelle strutture, nell’utilizzo della sorveglianza dinamica e nella creazione della prima mensa collettiva in un penitenziario italiano.
All’ente in questione spetta il 67% dei costi di progettazione e costruzione, mentre il restante 33% grava sulle casse dello Stato. Per la gestione di tutti i servizi sopracitati, invece, l’impresa scelta incasserà un canone annuo di 2,4 ml di euro nella cornice di un possibile canone di disponibilità annuo di 5,8 ml. Quest’ultimo indica la somma stanziata dallo Stato al soggetto privato nel caso in cui tutto il procedimento gestionale vada a buon fine, ovvero senza intoppi, ritardi e vizi di forma che comportino il non effettivo funzionamento e la mancata disponibilità, anche temporanea e parziale, della struttura.
Ma che significato ha il termine “disponibilità” se traslato dal vocabolario dell’economia all’interno della semantica dell’universo carcerario? Innanzitutto significa certezza che i servizi offerti ai reclusi siano presenti e funzionino bene, che le strutture siano agibili, pulite e integre ma, cosa forse più importante e tremendamente banale, che all’interno del carcere ci siano costantemente uomini e donne internati. Insomma, l’utilizzo dello strumento della “tariffa giornaliera fissa”, attraverso la quale lo stato paga all’azienda una somma relativa al numero di detenuti effettivi all’interno della struttura, utilizzato d’altronde nelle carceri private statunitensi o nei Cie italiani, ha una sua origine, un suo modello evolutivo le cui prime fasi sono rintracciabili proprio nel concetto di “disponibilità” sopracitato.
L’appalto per la costruzione del carcere di Bolzano se l’è aggiudicato l’impresa INSO – sistemi per infrastrutture sociali, un’azienda multinazionale, con sede legale a Roma, presente in diverse zone d’Europa e del mondo. L’impresa si occupa soprattutto di progetti di costruzione e fornitura di tecnologie nei settori della sanità, dell’industria e del terziario. Essa è inserita in una rete di aziende e imprese subordinate a Ferfina spa, meglio conosciuta come Condotte per l’acqua spa, leader italiano e mondiale nel settore delle costruzioni civili, autore di diverse opere devastanti in giro per il mondo come la Centrale Elettronucleare Montalto di Castro e quella di Trino Vercellese, l’alta velocità Torino – Milano e Roma – Napoli, il progetto Mose a Venezia e quello del ponte sullo stretto di Messina, solo per citarne alcune delle tantissime presenti sul territorio italiano. I terreni su cui sorgerà il penitenziario, invece, 18 mila metri quadri d’estensione, sono stati acquistati, a scopo speculativo dal Gruppo Podini e Rauch di Bolzano, anche grazie ai compensi della Provincia Autonoma.
La costruzione di un nuovo carcere è sempre un evento molto grave, in questo caso, però, assume un significato ben più profondo. Esso è il precedente che spianerà la strada ad una privatizzazione più ampia del sistema carcerario italiano con le conseguenze e gli effetti che tutti conosciamo.
Il processo in atto, tuttavia, non si conclude certo con la costruzione di un solo carcere “modello” al nord Italia; esso è una piccola espressione di un movimento più ampio dove gravitano altri fattori e dinamiche. Il carcere di Bolzano, insomma, non è l’unico indicatore di tale evoluzione, elementi diversi possono essere scovati anche altrove.
Gepsa in Italia
Da qualche anno a questa parte si è inserito all’interno del mercato della gestione degli immigrati in Italia, un nuovo ente gestore, dinamico e intraprendente, dotato di una storia e di un profilo molto significativi, l’azienda francese Gepsa, branca di Cofely, parte a sua volta di Gdf-Suez (Engie). Essa ha pervaso diversi ambiti del business legato ai flussi migratori, proponendosi come gestore di strutture differenti tra loro, dalle carceri per immigrati senza documenti fino ai Centri per richiedenti asilo. Attualmente l’azienda, coadiuvata dall’associazione siciliana Acuarinto, gestisce due dei Cie più grandi d’Italia, quello di Torino e Roma, un Cara a Milano (nei pressi dell’ex Cie di via Corelli) ed è presente in quasi tutte le gare d’appalto per la gestione degli altri Cie o centri per richiedenti asilo sparsi sul territorio nazionale. L’azienda, insomma, in pochi anni è riuscita con successo a penetrare sul territorio nostrano, imponendosi, grazie alle sue qualità, come leader nella gestione di strutture concentrazionarie. La storia della multinazionale francese e le competenze che ha sviluppato negli anni la dicono lunga su quanto essa possa rappresentare un modello aziendale ripetibile e, soprattutto, su quali scenari possa aprire la sua entrata nel panorama italiano.
Gepsa, infatti, è un’azienda nata nel 1987, a seguito di un mastodontico piano carceri in Francia. Attualmente gestisce oltralpe ben 13 penitenziari e 8 Centri d’identificazione ed espulsione, ed è impegnata nel project financing di 4 nuove prigioni, oltre ad essere amministratrice del lavoro di migliaia di detenuti.
Una presenza, la sua, che, come spesso accade, non si limita al semplice intervento nei bandi di gara, ma si concretizza in una vera e propria attività di lobbying nei confronti delle diverse istituzioni, una prassi il cui fine non è esclusivamente l’accaparramento degli appalti, ma la concreta modifica della legislazione vigente. Per un’azienda come Gepsa il mercato italiano della carcerazione, ancora sottoposto ad un modello chiuso economicamente e in pratica ristretto dalle grinfie del controllo statale, necessita di una profonda rivoluzione giuridica, un cambiamento che lo avvicini ai modelli liberali anglosassoni o perlomeno al modello misto francese, in cui Gepsa opera da anni.
Si è scritto tanto sulle pressioni che alcuni colossi della carcerazione operano nei confronti di istituzioni e partiti ed, infatti, non fanno notizia i milioni di dollari elargiti durante le campagne elettorali inglesi, australiane o nordamericane. Tuttavia, in Italia, di tale prassi si sa ben poco. A tal proposito, le notizie in circolazione su queste aziende sono limitate e non si riesce a capire quasi nulla dei loro movimenti sotterranei. Attività che indubbiamente esiste e risulta fondamentale ai fini dell’investimento. Nel maggio 2013, ad esempio, si è svolto presso la Casa circondariale di Saluzzo un seminario di approfondimento sul tema del Partenariato Pubblico Privato nella gestione dei servizi ausiliari penitenziari. All’incontro erano presenti varie autorità, personalità del Dap affiancate da alti rappresentanti sia di Gepsa che di Cofely. Al di là delle spiegazioni su cosa è e come potrebbe essere gestito il PPP, risulta chiaro che lo scopo di un seminario come questo e di altri incontri, sicuramente organizzati, sia ben altro rispetto ad un banale confronto.
Conclusioni
Che peso e che significato ha la presenza di un colosso della carcerazione come Gepsa in Italia e la sua partecipazione all’affare immigrazione? E soprattutto come legare questa figura a quanto detto finora, cioè ai lenti cambiamenti giuridici, alla comunità di Muccioli e al carcere di Bolzano?
La penetrazione dei privati all’interno del sistema carcerario penale non avviene dall’oggi al domani. Come ampiamente documentato, perché verificatosi in altri contesti, tale fenomeno pervade dapprima settori subalterni alla carcerazione. Un esempio classico è, come visto, la banale fornitura di servizi ai detenuti, un canale d’accesso che si può definire privilegiato, diretto e semplice. Ma ciò che rappresenta un vero e proprio banco di prova per le aziende è la gestione di strutture totali diverse dalle carceri, ma in qualche modo ad esse prossime e somiglianti.
In alcuni contesti, infatti, queste strutture hanno preso la forma dei centri di recupero per tossicodipendenti o delle case di riabilitazione, in altri luoghi, si sono invece palesati soprattutto nel settore, ambiguo e complesso sotto il profilo giuridico e legislativo, della detenzione amministrativa per immigrati irregolari.
Così, le aziende private, attraverso la gestione di comunità terapeutiche e Cie, hanno accumulato esperienza in questi settori, captato consenso e accettazione sociale e, una volta assicuratasi un’aurea di normalità, se non di umanitarismo in alcuni casi, hanno permeato il mercato carcerario più ampio. Questo è probabilmente il cammino percorribile in Italia da cooperative, associazioni e aziende, vecchie o nuove, nostrane o transalpine, il cui passaggio da una struttura detentiva per immigrati ad un carcere penale diventerebbe all’oggi molto più agile. Al momento molti di questi enti non dispongono del capitale necessario per la gestione di un penitenziario, ma qualcosa indubbiamente si sta muovendo.
Per questo motivo la presenza di Gepsa nella gestione dei Cie dovrebbe destare una forte attenzione.
Essa rappresenta uno dei punti nevralgici di una mappatura più ampia, una topografia del “campo” che collega il Cie di Roma al carcere di Bolzano, il Cara di Milano alla Comunità di Castelfranco, un universo concentrazionario privato in piena ed energica espansione.


 mezz'ora d'aria dalle frequenze di Radio città Fujiko 103.1 tutti i giovedì dalle 13 alle 13.30
mezz'ora d'aria dalle frequenze di Radio città Fujiko 103.1 tutti i giovedì dalle 13 alle 13.30